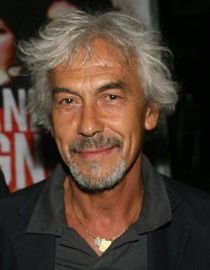Sámi Blood, ballata folk della giovane ribelle – La recensione
Fulgida opera prima di Amanda Kernell. Con una ragazza làppone che lascia la sua gente per imporsi nella Svezia dell’apartheid sociale anni 30
Per gli “altri” sono soltanto dei rumorosi mandriani di renne. Nel mondo, genericamente e con qualche imprecisione sulle dislocazioni etnico-geografiche, li chiamano làpponi. I sámi si realizzano in popolazione adorabilmente rupestre, di tradizioni rigorose e chiuse, dai costumi magnifici.
Che qualcuno sopporta e qualcun altro, molti anni addietro, ha letteralmente schifato. Gli svedesi, per esempio, come racconta Sámi Blood (in sala dal 30 novembre, durata 113’), fulgida opera prima di Amanda Kernell, cineasta trentunenne di Umeå che ama il nord del suo Paese e, appunto, quella gente, tanto da dedicarvisi - a giudicare dalla riuscita del film - con autentica passione.
Strappata alle renne per un “bagno nella civiltà”
La storia si sviluppa in un lungo flashback. Evocato da un’anziana professoressa di nome Christina (Maj‑Doris Rimpi) che torna dopo una vita nella sua terra sámi per assistere al funerale della sorella. E non vede l’ora di andarsene perché, in verità, quel posto lo ha lasciato, rifiutandolo, da ragazzina e non ci è più tornata.
Ma adesso è tempo di ricordi. E Christina si rivede bambina, col suo vero nome Elle-Marja (Lene Cecilia Sparrok) e la sua stridula lingua sámi correre dietro alle renne accanto alla sorellina Njenna (Mia Erika Sparrok) fra le tende coniche del suo insediamento tra le montagne ancora mezzo innevate.
Siamo negli anni Trenta, adesso. E le due sorelle, come tutti i ragazzini della loro età, vengono trasferite in un collegio svedese per imparare la lingua e venir dirozzate facendo un bagno di “civiltà”.
Un forsennato desiderio di integrazione
Perché in Svezia, all’epoca, i sámi sono considerati quasi alla stregua di selvaggi da educare e rispedire a casa loro impedendogli – con un forte sospetto di razzismo – di dimorare altrove. Elle-Marja, però, non ci sta e, vuoi per il carattere indomabilmente fiero, vuoi per il forsennato desiderio di integrazione confinante con quello di ribellione e rivincita, sfida la sua insegnante – l’attrice Hanna Alström (alla quale, in pieno processo di identificazione, ruba l’identità di Christina Lärarinnan e perfino un vestito), la scuola, il Paese intero: lasciando la sua terra e i suoi cari inclusa l’inseparabile sorella, involandosi a Uppsala e incominciando una nuova vita, non senza beccarsi ulteriori sberle d’intolleranza e di disprezzo da parte della bionda società urbana.
Favola d’impegno civile e saggio etnoculturale
Alla fine, comunque, Elle-Marja/Christina riesce a spuntarla su tutto e tutti come mostrano, all’inizio e nell’epilogo del film, l’immagine della sua età matura, il suo essere diventata definitivamente “Christina” e il percorso della sua memoria. Scene di un ritorno già vissute nel bel “corto” della regista Stoerre Vaerie (Northern Great Mountain) presentato con gran successo alla norvegese rassegna di Tromsø. In un film che, dilatando proprio quel racconto e usando il corto come prologo e chiusura, riesce ad associare elementi e motivi di fascino diversi, dal semplice e pur profondo saggio etnoculturale alla favola d’impegno civile, alla ballata folk nei paraggi d’un popolo seduttivo e bellissimo, fedele a se stesso, conservativo e trasversale sull’intera linea del Grande Nord splendidamente ritratta nella fotografia di Sophia Olsson e Petrus Sjövik.
L’invisibile linea di confine tra due culture
Kernell, di madre svedese e padre sámi, galleggia da sempre su due culture e in fondo questa storia è anche la sua. Se non nella traiettoria della protagonista, sicuramente nella sua sospensione, nel suo stare al qua e a di là di una no man’s land invisibile ma molto più netta di qualsiasi barriera materiale.
Temi e problematiche che questo originalissimo e intenso spartito cinematografico – che ha giustamente spopolato ai principali festival internazionali - tratta con grazia, senza però sottrarre spessori ad una fervida energia emotiva e ad una partecipazione , a tratti commossa, ai casi della giovanissima transfuga che sa cantare lo yoik nella sua forma unica di vocalità tradizionale, vive un’appartenenza che diventa motivo stesso di contrapposizione e di conquista “altra”, coltiva una tenacia che le consente di materializzare un sogno.