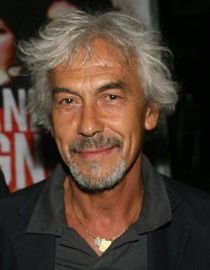Cento anni, al cinema l’Italia che muore e rinasce – Recensione
Davide Ferrario e il suo bel documentario anti-celebrativo su Caporetto e sulle parabole di un Paese che ogni volta ricomincia a vivere dopo le disfatte
A cosa servono i morti. Senza punto interrogativo. Davide Ferrario, dunque, non se lo chiede. Piuttosto ci medita e ci rimugina su rotolando lungo il suo Cento anni (in sala dal 4 dicembre) che dura circa un’ora e mezza ma potrebbe prolungarsi per giorni con una miriade di casi, di lezioni e di ammonimenti sul significato di Caporetto, i suoi sensi secondi e la sua simbologia storico-sociale.
Non solo e non tanto un documentario escogitato, appunto, nel centenario di quella disfatta; quanto un piccolo saggio anti-celebrativo diviso in capitoli sui corsi e i ricorsi della vita civile italiana, ricordando che il termine fatidico è stato mutato in definizione per ogni evento catastrofico che ha colpito nel tempo il Paese. Preludendo, invariabilmente, alla successiva rinascita. A questo, servono i morti. In una riflessione che aiuti a capire, di fatto, perché sono morti.
I sacrari goriziani e la memoria dei caduti
Il film, che deve la sceneggiatura allo stesso Ferrario e a Giorgio Mastrorocco, parte comunque dalla sconfitta di cent’anni fa, punto di svolta nella Prima Guerra Mondiale. E lo fa con le immagini riprese dai grandi sacrari goriziani, quello dell’Ara Pacis Mundi di Medea dove Mario Brunello esegue al violoncello il canto armeno per la Resurrezione Havun Havun, quello di Redipuglia con la sua sterminata sequenza di Presente, entrambi nei loro simbolici tracciati attorno alla memoria dei caduti delle guerre.
Caporetto, Ferrario la ricorda a modo suo, con il rigore ossuto del proprio far cinema, arrivando al “dopo”, al suono delle campane che annunciano la fine del conflitto come la liberazione da un incubo, senza fare differenza tra vittoria e sconfitta se non a rilevare la constatazione di essere ancora vivi. Lasciandosi alle spalle le sciagure di migliaia di contadini diventati profughi nel giro di poche ore, delle donne umiliate e stuprate, dei “figli della guerra”, dei reduci della disfatta – i cosiddetti ripudiati di Caporetto - considerati traditori in patria e morti di fame in prigionia.
L’altra guerra che comincia dopo l’armistizio
Nella sconfitta diventa più chiaro vedere chi siamo, recita il film. Introducendo l’altra guerra, quella vera, che incomincia dopo l’armistizio dell’8 settembre, col suo carico di veleni, di vendette e di sangue prolungati negli anni a venire, come racconta l’ex chitarrista dei CCCP e CSI Massimo Zamboni (che con Fabio Barovero fondatore dei Mau Mau compone le belle musiche) a proposito dell’omicidio di un suo zio fascista colpito alle spalle nel ‘44 da due partigiani, uno dei quali, all’inizio degli anni 60, assassinerà poi l’altro.
Italia senza pace. Da Caporetto al flagello del Vajont del ‘63 e alla strage di Piazza della Loggia a Brescia, nel ’74, con le testimonianze dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime ancora a chiedersi “perché?” in una successione d’interviste rigorosamente in bianco e nero mescolate con l’audio dello scoppio, dei silenzi, delle grida, con le scene di strazio e di sgomento.
Le grandi tragedie dell’Appennino e del Meridione
E, ancora, nell’ultimo capitolo altre tragedie, stavolta felpate ma non meno dolorose: quella dell’Appennino delle frane, dei terremoti e del dissesto idrogeologico, il paradosso del centro storico di Bisaccia in Irpinia, che dopo il sisma del 1980 s’è svuotato e i suoi abitanti trasferiti in una parte nuova del paese chiamata “Piano regolatore”, sicché c’è un luogo con un suo nome senza abitanti e un altro luogo con abitanti ma senza nome. E la Caporetto demografica del Sud, luogo d’inganno e prodigio, emblema di un’Italia finalmente in pace ma affollata di non-nati raccontata dal poeta, scrittore e regista Franco Arminio.
Mobilità, alternanza e sintesi storica
Tutto questo, Davide Ferrario lo racconta con affetto italiano, fuori da contesti polemici, con uno spirito molto vivace di osservazione, studio e ricerca; annotando particolari, ascoltando le genti, lasciando aperta la prospettiva di quella rinascenza che da sempre s’avvicenda, da queste parti, al decadimento e allo sbaraglio. Una mobilità, un’alternanza e una sintesi storica che il film coglie in un costrutto di meditate dinamiche narrative e di montaggio (di Cristina Sardo), mescolando scene belliche con filmati amatoriali, brani dal vecchio Maciste alpino (1916) di Luigi Romano Borgnetto e Luigi Maggi con l’attualità di una fotografia (di Andrea Zambelli e Andrea Zanoli) nitida e ricca di prospettiva: in un’Italia attraversata quasi per intero dal Friuli alla Lucania passando per il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Campania. A ciascuno le sue calamità, a ciascuno la voglia e la forza di ricominciare, come mostra l’ultima scena – visivamente alla Zabriskie Point ma in tutt’altro contesto – con le sue nuove generazioni intente ad una allegorica risalita.