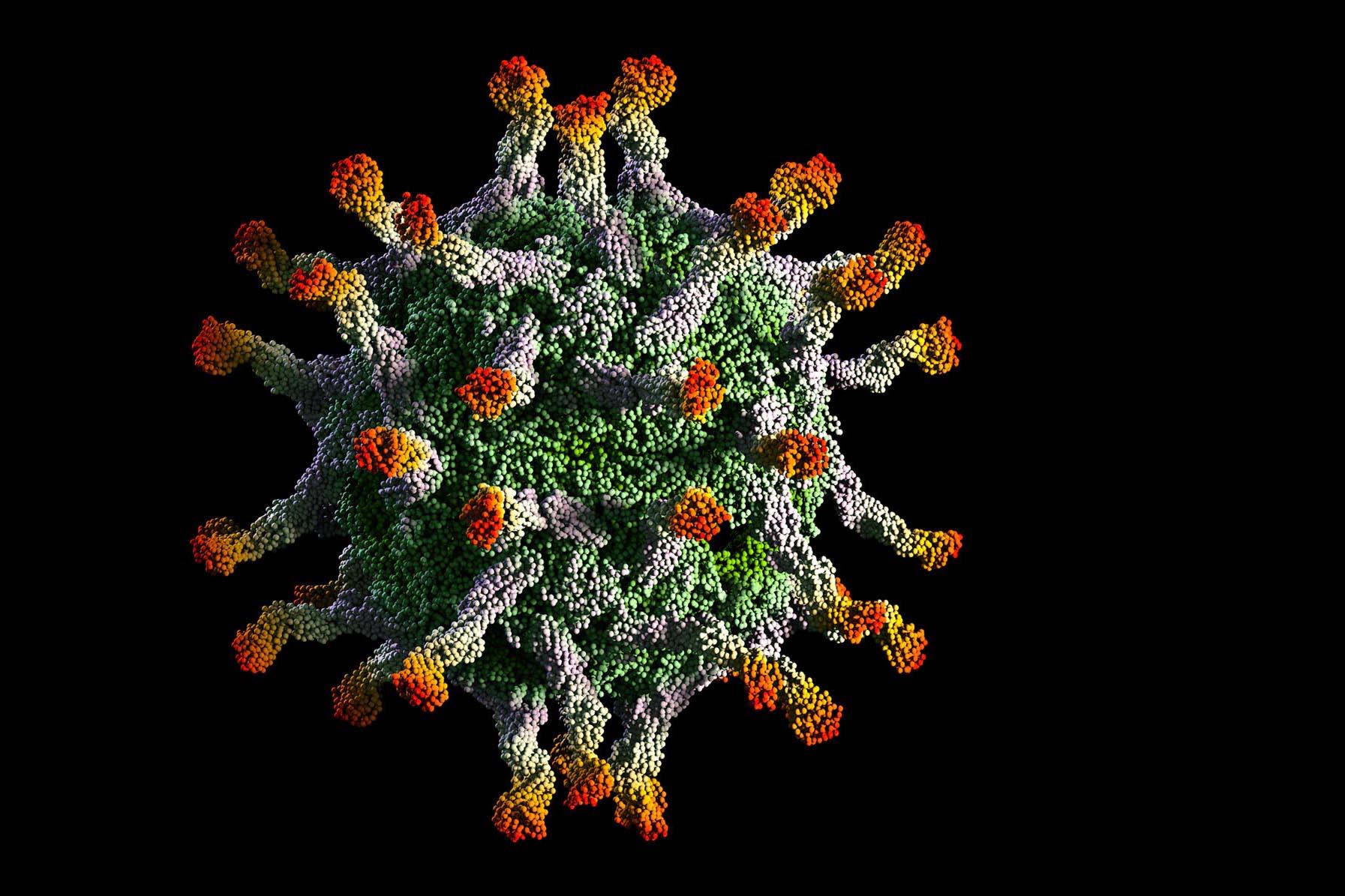Un virus che si riteneva un retaggio del passato oggi è ricomparso in Paesi «ricchi» come Inghilterra, Stati Uniti e Israele, e benché l’immunizzazione resti l’unica arma, può talvolta contribuire al diffondersi della malattia in forma grave.
Non bastava il Covid? Certo che sì, ma i microrganismi, «pensando» solo a riprodursi, aspettano sempre l’occasione giusta. Così, dopo l’acrobatico salto di specie del Sars-CoV-2 nell’accogliente organismo umano, ora si è ripresentata un’infezione che, nei Paesi occidentali, sembrava un ricordo del passato: il virus della poliomielite è tornato a colpire, sia pure in maniera assai meno cruenta di una volta, in Inghilterra, Stati Uniti, Israele.
Qualche dettaglio in più: a New York, nella contea di Rockland, un giovane, immunodepresso, è rimasto paralizzato a una gamba, e il virus è stato individuato nelle acque reflue di altre cinque contee, spingendo il governatore della città Kathy Hochul, lo scorso 9 settembre, a dichiarare lo stato di emergenza. A Londra lo hanno trovato nelle acque di scarico di 8 distretti (nessun caso clinico). A Gerusalemme si era infettato, in primavera, un bambino di quattro anni, e altri sei piccoli erano risultati positivi, ma senza sintomi. E benché, come scrive Science, «grossi focolai di poliomielite sono improbabili nei Paesi ricchi», Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, ha avvertito che «la presenza del virus è un campanello d’allarme per tutti. Coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le dosi, dovrebbero farle il prima possibile».
La malattia tra il 1940 e 1950 uccideva o paralizzava, ogni anno, mezzo mezzo milione di persone sul pianeta. In genere, la maggior parte dei contagiati non mostrava sintomi, altri – nel giro di qualche settimana – avevano febbre alta e vomito. Ma in un caso su 100-200, grosso modo, il virus può attaccare il sistema nervoso, causando paralisi o, più di rado, morte se a essere bloccati sono i centri della respirazione. In Italia, nel 1958, ci furono oltre 8 mila casi – il nostro Paese fu dichiarato «polio-free» il 21 giugno 2002 – ma ancora oggi può capitare di vedere qualche persona che, ammalatasi durante l’infanzia, è rimasta disabile.
Ci si chiede: se il virus era stato debellato, perché oggi è di nuovo in giro? Ad aprirgli lo spiraglio per tornare a diffondersi, paradossalmente, è proprio l’arma con cui siamo riusciti a tenerlo a bada quasi ovunque (tranne che in Pakistan e Afghanistan): il vaccino. O meglio, uno dei due utilizzati per immunizzarsi. «Intanto chiariamo che “eliminare” non vuol dire eradicare» precisa Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all’Università di Firenze e direttore del Dipartimento di Scienze della salute. «Nel primo caso, significa che per almeno tre anni in una determinata area geografica o continente non si sono più verificati casi di malattia clinica. In Stati Uniti e in Europa, per esempio, non si erano più visti malati di polio, ma non significa che non ci possano essere i virus. Nell’eradicazione invece non solo non c’è più la malattia, ma anche l’agente infettivo è stato eliminato dalla faccia della terra, come nel caso del vaiolo».
E qui bisogna fare un po’ di storia per capire la situazione di oggi. Contro la polio sono stati utilizzati, negli ultimi 60 anni, due vaccini: il primo, introdotto nel 1955, era quello messo a punto dal virologo Jonas Salk, e si iniettava nel muscolo. Il secondo, opera di Albert Sabin, nel 1962, era quello in goccine (il famoso zuccherino che si dava ai bambini). La differenza è sostanziale: il vaccino di Salk si basa sul virus inattivato, ossia morto; quello di Sabin è costituito invece dal virus «attenuato» ma vivo, anche se ha perso la sua virulenza. «Il virus della polio era ovunque, per combatterlo abbiamo dovuto usare il tutto mondo il vaccino Sabin, che era molto adatto» continua Bonanni. «Stimolava l’immunità intestinale, e in caso di contagio da il virus “selvaggio”, per esempio da alimenti inquinati, trovava gli anticorpi nell’intestino e veniva bloccato prima ancora di entrare in circolo. Il Sabin fu indispensabile nelle fasi iniziali, perché era più efficace nel ridurre il contagio a livello collettivo oltre che individuale, e così si è ottenuta l’immunità di gregge.
Il virus di origine «vaccinale» veniva poi eliminato dall’organismo, finiva nei liquami fognari e tornava quindi nell’ambiente. In tal modo, furono immessi nelle acque reflue tantissimi virus attenuati; il che fu un bene perché la versione «bonaria» del microrganismo alla fine scalzò il competitor selvaggio, assai più cattivo (quest’ultimo resta, come si diceva, in Pakistan e Afghanistan). Ma in biologia, l’evoluzione detta sempre la linea. Così capita che il virus «buono» di origine vaccinale possa talvolta tornare aggressivo tramite un processo di «retromutazione», potenzialmente capace di causare la malattia clinica. Succede, periodicamente, in paesi come Asia e Africa, che immunizzano tuttora con il vaccino orale.
Nei Paesi occidentali, compresa l’Italia, quando la poliomielite iniziò a circolare meno si abbandonò questo vaccino e si continuò con l’altro, in cui il patogeno era ucciso. «Anche perché continuando a immettere nell’ambiente il virus vaccinale “buono” c’era il rischio che potesse retro-mutare» racconta Bonanni. A New York, il giovane newyorkese colpito da paralisi è probabilmente venuto in contatto con qualcuno che si era esposto al vaccino Sabin, magari all’estero. Basta che un bambino così immunizzato sia arrivato negli Stati Uniti, abbia rilasciato con le feci il virus attenuato che ha poi iniziato a diffondersi. La preoccupazione degli esperti, al momento, non è tanto nel ritorno della malattia a livello globale, ma in una sua recrudescenza laddove la copertura vaccinale è bassa. Di fatto, fa sapere il New York Times, in molte aree di New York l’immunizzazione anti-polio si ferma al 65 per cento (e in certe zone non supera il 5 per cento).
Ma, una volta contagiati, ci sono terapie in qualche modo efficaci, come nel caso del Covid? La risposta è no. Contro il virus della polio non esistono antivirali, solo tentativi di restaurare la funzionalità residua dei centri nervosi colpiti dal’infezione. «Questo virus è molto abile a individuare soggetti non immunizzati, ed è lì che il ceppo di origine vaccinale può diventare pericoloso» ha spiegato Walter Orenstein, infettivologo della Emory University di Atlanta, in un’intervista a Nature. E sempre Nature ricorda come negli anni Novanta si verificò nei Paesi Bassi un focolaio di polio, con 59 episodi di paralisi e due morti, 14 anni dopo l’ultimo caso conosciuto.
Temere che la poliomielite torni in modo massiccio come in passato è eccessivo, dunque. L’importante è non concedere al virus l’opportunità di accumulare mutazioni fino a riguadagnare la sua capacità paralizzante. Solo così potremo davvero eradicarlo dal pianeta, come si sta cerca di fare da anni. «Forse ci riusciremo entro la fine di questo decennio, è cruciale però continuare a vaccinare con alte coperture» conclude Bonanni.