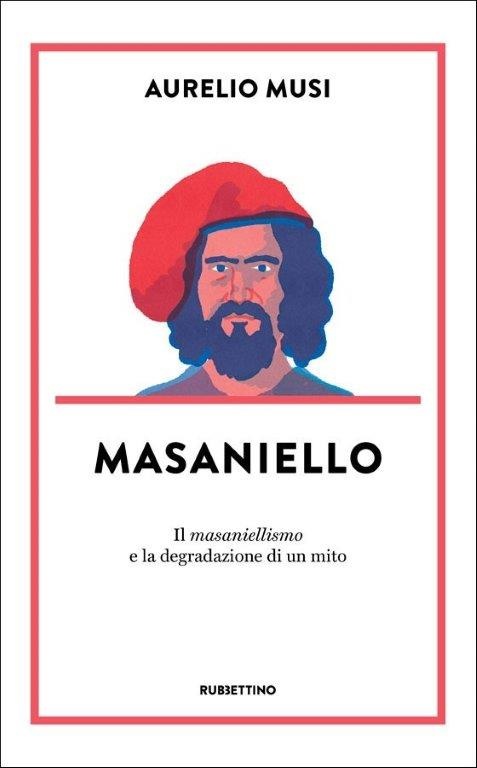Lo storico Aurelio Musi rievoca le gesta del celebre ribelle partenopeo. E individua i Masaniello dei tempi nostri: da Vincenzo De Luca a Matteo Salvini, da Silvio Berlusconi a Luigi De Magistris.
«Può apparire colpito da un delirio di onnipotenza, ma in realtà il suo potere di attrazione è enorme». Il professor Aurelio Musi fa una radiografia di Vincenzo De Luca «lo stracandidato», come si è autodefinito il presidente della Regione Campania. Già ordinario di Storia moderna e preside della Facoltà di Scienze politiche nell’ateneo salernitano, allievo di Giuseppe Galasso, Musi è il massimo esperto di Masaniello. Nel suo ultimo volume, Masaniello. Il Masaniellismo e la degradazione di un mito (editore Rubbettino), ricostruisce la vita del protagonista della rivolta napoletana del 1647, la formazione e lo sviluppo del suo mito. Panorama lo intervista per capire perché Masaniello è diventato il prototipo del ribelle e chi sono i suoi epigoni contemporanei.
A 31 anni dalla pubblicazione, la sua monografia La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca resta una pietra miliare.
«Quel volume, nel 1979, ebbe un effetto dirompente nella comunità degli storici, semplicemente perché contribuì a fare luce su un personaggio storico collocato nell’esatto punto di incontro di mistero e certezza, fantasia e realtà, offrendo, da una parte, un sensibile aggiornamento degli studi e, dall’altra, una nuova e interessante prospettiva analitica. Masaniello andava in ogni caso rivisitato».
Perché Masaniello resta un enigma?
«I motivi sono oggettivi e soggettivi. Di Tommaso Aniello D’Amalfi (patronimico e non nome del luogo di nascita, come comunemente si crede) si sa assai poco: le fonti documentarie sono carenti. Quanto ai motivi soggettivi, bisogna ricordare che il personaggio è volubile e non è facilmente decifrabile nei suoi comportamenti durante la rivolta napoletana che lo vide protagonista dal 7 al 16 luglio 1647».
Masaniello-Davide sfidò Golia con coraggio.
«Guidò con mano ferma una parte non secondaria della popolazione napoletana, mediando tra anime diversissime: mercanti, artigiani, piccoli impiegati, ma anche plebe non strutturata. Seppe, sia pure per pochi giorni, unificare le rivendicazioni antifiscali e antinobiliari del popolo napoletano».
Morte di Masaniello, fine della rivolta?
«Neanche per idea! La rivolta andò ben oltre la vicenda personale di Masaniello, investì le campagne del Mezzogiorno: nell’ottobre 1647 fu proclamata la indipendente “Real Repubblica Napoletana” sotto la protezione del re di Francia Luigi XIV; il 6 aprile 1648 gli spagnoli ripresero possesso della città e delle province del viceregno, dopo aver bombardato Napoli dal mare».
Paura e follia.
«Il mio nuovo studio si basa anche su un’analisi psicologica di Masaniello e dei diversi gruppi sociali protagonisti degli eventi, utilizzando i concetti di angoscia, paura, spavento. Freud è citato a mani basse, a partire dal suo Al di là del principio del piacere».
«Ricordo i racconti di Alexandre Dumas La piazza del Mercato e La Chiesa del Carmine e il romanzo di Horace Roscoe St. John, Masaniello of Naples. The record of a nine days Revolution, pubblicato a Londra nel 1865».
Anche al cinema c’è stata gloria.
«Per quanto fumoso, vi fu anche un progetto faraonico di un film su Masaniello, sceneggiato da Ettore Giannini, Giuseppe Marotta ed Ennio Flaiano, il cui interprete principale avrebbe dovuto essere Paul Newman. La casa di produzione era la Lauro-Amoroso Cinematografica Spa, nata nel 1958 come parte dell’attività del comandante armatore Lauro, sindaco di Napoli dal 7 luglio 1952. Da Lauro, prima personificazione di Masaniello, il fenomeno del masaniellismo prese piede».
Uno e centomila…
«Da anni si associa Masaniello a personaggi diversi del mondo della politica e non solo: da Cirino Pomicino ad Alessandra Mussolini (definita “a’ Masaniella nera”). Poi sono giunti Silvio Berlusconi che si è auto-associato a Masaniello più volte e de Luigi De Magistris che pure, almeno in una prima fase, ha accettato di essere considerato un “nuovo Masaniello”».
Berlusconi con la sua celebre bandana estiva…
«All’epoca, sulle rive sarde di Porto Rotondo, nella sua Villa Certosa, Berlusconi dava questa impressione. Certo, dovremmo chiedergli se ambiva al Masaniello alfiere della libertà o a quello del difensore della giustizia!»
E De Magistris, con la fascia attorno al capo!
«Scaramantico come ogni napoletano, si è accostato al capopopolo soltanto per attualizzare chi si ribella al potere oppressivo, non certo per ripeterne gli esiti finali. Sapeva bene che fine fece Masaniello!»
E non mi cita Vincenzo De Luca, il governatore?
«Caspita, siamo alla fenomenologia! Più che essere associato a Masaniello per il suo piglio autoritario, e per la vocazione populista che si sposa col senso borbonico dell’autorità, come ha scritto Giuliano Ferrara, De Luca stesso si è auto-definito “lo stracandidato”, esattamente come Masaniello nei giorni della sua follia. Può apparire colpito da un delirio di onnipotenza, ma in realtà il suo potere di attrazione è enorme».
Potere di attrazione, in che senso?
«Non solo metaforico! Pensi che qualche recente acquisto alla sua causa, proveniente addirittura da Forza Italia, come il consigliere regionale Flora Beneduce – l’ex fedelissima di Luigi Cesaro, per intenderci – lo ha addirittura paragonato all’albero della vita».
Scomodiamo la Bibbia?
«Mi creda, è successo a giugno. Il governatore innalzato a simbolo di vita eterna, albero che vivifica creazione e conoscenza. E sappiamo che non solo la Bibbia lo cita, ma anche i testi sacri fondamentali di altre religioni».
Non mi dica.
«Guardi che siamo alla reincarnazione di Masaniello allo stato puro. Perché possiede la capacità di estendere il consenso, unita all’insofferenza per qualsiasi forma di mediazione ed alla tendenza a scavalcare istituzione e partiti. E mi dica lei se questo non è populismo allo stato puro».
«Le analogie in storia sono pericolose. Certo è suggestiva l’idea che le crisi politiche possano innescarsi talvolta in luoghi che poco hanno a che fare con le istituzioni della rappresentanza democratica».
Sintetizziamo, professore.
«Masaniello è stato oggi trasformato nel ribelle che fa solo “ammuina”, come si dice a Napoli, privo di razionalità politica, diretto da altri, ma anche nel cliché del napoletano-tipo, rappresentazione di tutti gli stereotipi possibili e immaginabili. Masaniellismo è diventato anche sinonimo di populismo. Insomma il povero pescivendolo starà rivoltandosi nella sua tomba!»
Chi è Aurelio Musi

Nato nel 1947 a Castelfranci (Avellino), nel 1970 si è laureato in Lettere e filosofia con gli storici Giuseppe Galasso e Pasquale Villani, sotto la cui guida iniziò a svolgere studi sul pensiero giuridico e politico napoletano del Seicento, per poi dedicarsi ai rapporti fra Stato e pubblica amministrazione nell’Europa d’antico regime. Nel 1979 vide la luce il lungo saggio Stato e pubblica amministrazione nell’ancien régime, considerato base scientifica del dibattito internazionale su Stato e assolutismo. Dopo aver focalizzato l’attenzione sugli aspetti della storia del Mezzogiorno spagnolo, tra i quali emerse con forza la figura di Masaniello e della sua rivolta, Musi ha rivolto anche particolare attenzione e sensibilità ai problemi di teoria e di metodo della ricerca storica. Autore, con Giuseppe Galasso, di manuali di storia per la scuola media inferiore e superiore, è stato dal 1994 professore ordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno, di cui è stato per sei anni preside. Ha insegnato in università americane ed è socio della Real Academia de la Historia di Madrid. Ha ricevuto numerosi premi internazionali. Masaniello. Il masaniellismo e la degradazione di un mito (Rubbettino, 2019) è l’ultima riflessione in materia.