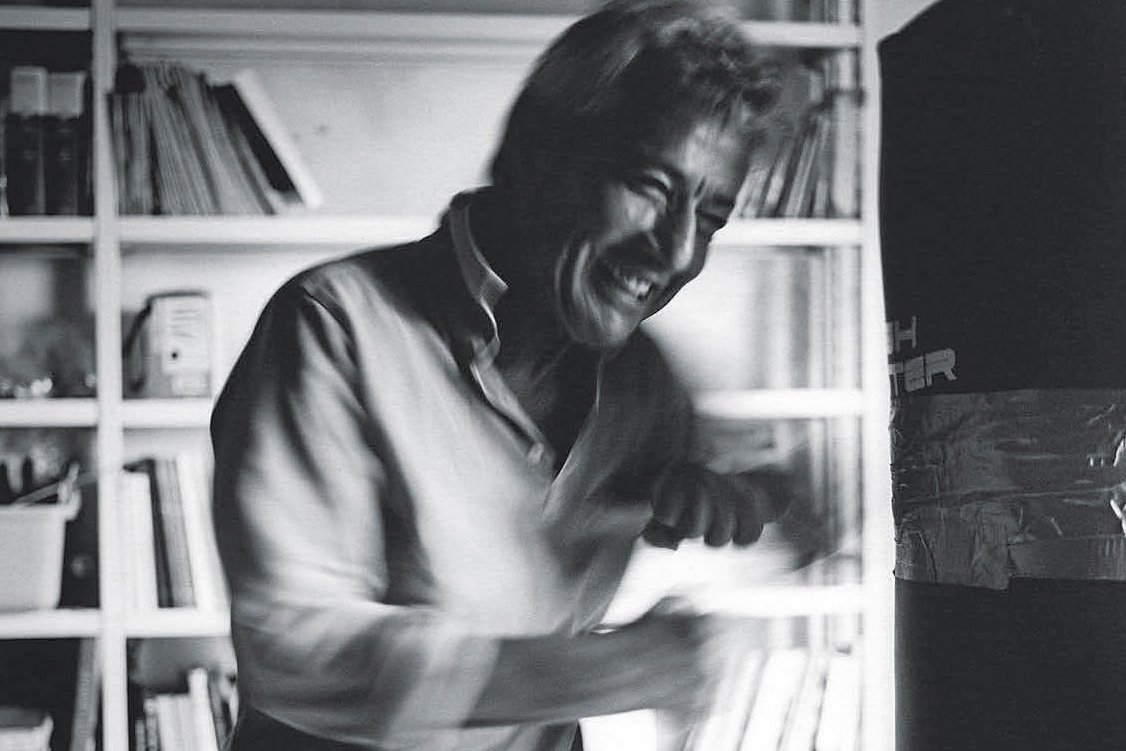OTTAVIO FATICA restituisce in italiano i capolavori di scrittori come Herman Melville, Rudyard Kipling o Louis-Ferdinand Céline, di cui ha appena dato la versione del romanzo inedito Guerra. «Ho l’ossessione della lingua e cerco di rendere la vera voce degli autori. È un lavoro intenso, intellettuale ma anche fisico…».
Sentite come fa urlare il capitano Achab, mentre il leggendario personaggio di Herman Melville sta per arpionare Moby Dick: « Oh, oh! Da tutti i vostri confini più remoti riversatevi ora qui, prodi marosi dell’intera mia esistenza trascorsa: coroni la mia morte alto un frangente! Ti vengo incontro rollando, balena che tutto distruggi e non riporti vittoria; fino all’ultimo io lotterò con te». Oppure come sintetizza il pensiero di Ferdinand gravemente, il protagonista autobiografico che Céline mette al centro di Guerra, il romanzo ritrovato dello scrittore francese più maledetto che ora ha pubblicato Adelphi: «Ribellarsi non serviva a niente. È stata la prima volta che ho dormito, in quella melassa di granate che passavano fischiando, in tutto il rumore che hanno voluto fare, senza perdere del tutto conoscenza, cioè insomma nell’orrore»…
Sì, Ottavio Fatica fa parlare così i suoi grandissimi scrittori, lui che è tra i più brillanti traduttori che ha lavorato su «classici» come Rudyard Kipling e Lord Gordon Byron, o poeti come Gottfried Benn, Robert Frost, Wystan Hugh Auden, William Blake e Osip Mandel’štam. Dategli un autore difficile e lui, in italiano, ne tirerà fuori la fibra e la linfa. Dalla sua casa umbra di Narni, dove vive con la moglie, Fatica si sposta poco («Prima andavo ogni settimana a Roma, ma poi ne ho sentito sempre meno il bisogno. Sto bene qua in campagna, tra monti Sabini e fiume Nera»). Ha i suoi 30 mila libri, una gatta che lo ispira, gli esercizi di Jeet Kune Do, l’arte marziale di Bruce Lee che pratica con misura ma costanza («Da quasi mezzo secolo ormai, e devo dire che mi sono divertito tanto…»). A 72 anni è tutt’altro che stanco di andare in cerca delle parole migliori, giuste, per il mestiere oscuro ma vitale senza cui potrebbe leggere ben poco della letteratura del mondo.
Cos’è per lei la traduzione? Un’avventura, non solo intellettuale, bella ma anche infida. Se la vivi con intensità ti dà persino effetti psicosomatici! Il traduttore è come se fosse l’autore che riscrive sé stesso. Dopo la prima stesura chi scrive rivede, sente se la frase o il verso suonano bene. Per chi lo deve trasformare in un’altra lingua l’operazione è analoga.
Come ha cominciato?
Alla fine degli anni Settanta portai a Roberto Calasso dell’Adelphi alcune traduzioni di prose e poesie di William Blake e di Céline. Brevi, acerbe, ma non erano male. È che dopo il liceo linguistico non volevo più studiare ma neanche lavorare. Tradurre mi pareva un buon compromesso. A Calasso piacqui perché non volevo pubblicare un libro, né bramavo piazzare racconti su riviste come Nuovi argomenti… Ero presuntuoso, certo, ma lo incuriosivano le mie scelte «poco italiane», il teatro di Antonin Artaud, le poesie di Mandel’štam e Benn. Mi piacevano i testi orientali, strani. Con Calasso ci siamo capiti al volo e siamo andati avanti per più di 30 anni.
La sua traduzione più complessa?
Certi racconti dell’ultimo periodo di Kipling. Poi c’è Moby Dick. Per le sue 666 pagine non hai un attimo di fiato: sono nodi marinari così stretti che ti soffocano. Ci ho messo un anno. C’è da dire che se traduci questi grandi autori ti rendi conto che tutti delirano con la lingua. Melville scrive come un autore del Seicento, come il filosofo Thomas Browne o lo stesso Shakespeare. Hanno qualcosa di più, il genio, e qualcosa di meno, la semplicità. E Melville dice cose nell’America puritana che nemmeno il peggiore eretico aveva mai osato pensare. Bellissime e spaventose.
Era come fosse sulla tolda del «Pequod» quando lo traduceva?
Melville ha un immaginario inarrivabile. Mentre sulla superficie del mare si svolge la caccia a un capodoglio, al di sotto ci sono le balene che stanno partorendo. Neanche gli effetti del cinema di oggi renderebbero quella visionarietà. Forse solo un pittore come Hieronymus Bosch avrebbe avuto un’idea così.
Finita una traduzione è soddisfatto?
Mah… Io mi ritraduco a distanza di anni. Leggo anche quello che hanno fatto gli altri, soprattutto per fare qualcosa di diverso. Perché se varie versioni di Kipling si somigliano, be’ è segno che il cervello di chi traduce si è addormentato! L’inglese è una lingua impressionistica! Ogni libro contiene echi della regione d’origine dell’autore, espressioni dell’epoca, echi di altri libri. È un gioco di rimandi e se ne scoprono sempre di nuovi. Se poi ci sono dieci traduzioni io mi posso permettere di essere barocco come Melville. Altrimenti, quando affronto un Samuel Beckett come faccio a rendere la secchezza assoluta della sua frase?
Lei è anche poeta. Qual è il rapporto tra quello che traduce e i versi?
Devi avere sensibilità per ciò che leggi, ma poi liberarti dal tuo modo di scrivere. Ho tradotto versi di americani come Frost, inglesi come Auden. Loro sono tridimensionali, ma leggo spesso traduzioni bidimensionali senza profondità. C’è la paura di utilizzare parole auliche o volgari. Bisogna tradurre, non «tradire» la loro lingua. Quando incontri parole difficili in Carlo Emilio Gadda, le accetti: in una traduzione pare di no… Invece, con la tua versione, devi entrare nel ritmo dell’autore. Corri dei rischi d’accordo, ma con più soddisfazione.
Céline è ancora un tabù?
Dalle reazioni che ci sono state in Francia, direi di sì. Gli editori anglofoni nemmeno lo pubblicano. In America sono così bacchettoni che lo considerano un reietto. E sì che hanno autori ben più sconci. Non ci dovrebbe essere questa discriminazione. Succede per la stessa forza che ha Céline. Il retropensiero è: questo farabutto è così bravo che allora bisogna odiarlo!
Che difficoltà ha incontrato nel rendere in italiano Guerra?
La dimensione dell’«incompiuto». Il romanzo è a uno stato magmatico, in alcuni passi: non lo puoi aggiustare troppo, sennò lo falsifichi. Céline userà dieci congiuntivi in tutte le 134 pagine. E io l’ho lasciato così. Leggendolo, ti rendi conto che lo stile sta diventando quello che l’autore cercava. Ogni tanto, però, la narrazione gli si sbriciola tra le mani. Allora bisogna «sgrammaticar con estro». Un altro problema è stato la volgarità eccessiva. Si tratta di uno scrittore estremo. Mette in scena il sesso in mezzo ai cadaveri… Io, però, con il turpiloquio non ho problemi. Nei romanzi di Céline troppi vogliono leggere le cose orribili, senza che siano politicamente scorrette. Ma lui viveva a Montmartre, e fa parlare i personaggi come la gente comune. «Rivomita» le loro parole con la sua bravura assoluta.
Ora sta lavorando alla traduzione di Londres, l’altro inedito celiniano…
Somiglia al suo Guignol’s band perché è lo stesso periodo, del 1936-37, in cui scriveva i suoi libelli antiebraici. È picaresco e ci saranno sorprese. Per esempio, con il personaggio di un ebreo del quale Céline dice cose bellissime. Perché quell’uomo gli fa scoprire la medicina, a lui bambino fa leggere i libri, perché gli presta attenzioni che neanche i suoi genitori gli davano.
Lei pare ossessionato dalla lingua.
Purtroppo sì (ride). Ti svegli la notte e pensi a quello che hai tradotto, se va bene. Sento un jingle in tv e dico: perfetto! Proust ha scritto: il dovere e il compito di uno scrittore è quello di un traduttore. A invertire l’ordine dei fattori il risultato cambia poco, almeno per il sottoscritto: il mio compito di tradurre è quello di uno scrittore. A un libro non tradotto manca qualcosa. Manca l’ombra… Tu gliela devi dare.
Il segreto di una buona traduzione?
Dopo che hai impiegato anni a imparare il mestiere, devi essere anche baciato dalla fortuna. Partecipare a una «seduta spiritica» con lo scrittore, sennò la traduzione non è compiuta. Viene una cosa discreta, ma nell’arte il discreto non dev’esserci. Poi non sempre ci si arriva. È lì che è necessario un piccolo vento favorevole. E io vorrei poter rendere la vera voce di ogni scrittore.
Chi tradurrebbe volentieri?
Forse Shakespeare. Il teatro in generale. Sono fatalista: se devono accadere, anche le cose belle arrivano.
Che cosa le piace del suo mestiere?
I tempi dilatati. Magari un giorno vuoi pensare e non traduci una riga. Poi, al contrario, acceleri: sei talmente preso che neanche dormi e lavori fino alle 5 di mattina. All’inizio io parto lento, spento, come quando ho cominciato con Tolkien. Mi chiedevo: come riuscirò a tradurre 1.500 pagine quando per adesso ne ho fatte appena 13?
E qual è il messaggio che ci legge nel Signore degli anelli?
Non ci indurre in tentazioni rispetto al potere! Tolkien ha messo Frodo davanti al dilemma di un’entità superiore che gli fa desiderare il potere. La tentazione… Mi fa pensare anche come la Chiesa, dopo duemila anni, ha cambiato formula al Padre nostro, da «non ci indurre in tentazione» a «non abbandonarci». Che vuol dire? Dio è cattivo e ci mette alla prova? Se faccio il traduttore e trovo una frase che non condivido, mica la censuro o la stravolgo. Non si può adattare il male, ingentilire la cattiveria per paura.
La pratica delle arti marziali che ruolo hanno in tutto questo?
Mi servono per la disciplina. Sono la parte fisica della mia vita, come l’amore per gli animali che mi riporta alla natura. Si dice che li antopomorfizziamo. Ecco, io mi «animalizzo». Altrimenti ci si butta sulla traduttologia… E che senso ha…?
Il suo lavoro si definisce bene anche con il cognome che porta: Fatica.
Sì, se ne fa un po’, ma va bene così. Volevo prendere il cognome di mia madre. Ma poi l’aveva fatto già Céline! Per fortuna ho lasciato perdere.