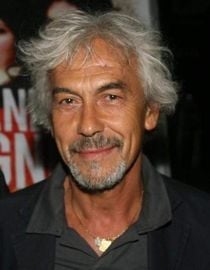Tutti riuniti: da sinistra Antoine (Laurent Lafitte), Gérard (Benjamin Biolay), Adar (Bruno Putzulu), Louis (Nicolas Bedos), Francis (Guy Marchand), Julie (Élodie Frégé) e Nelly (Marie-Christine Barrault)

Antoine (Laurent Lafitte, a sinistra) con Louis (Nicolas Bedos)

Gérard (Benjamin Biolay) con sua madre Nelly (Marie-Christine Barrault)

Due genitori troppo “presenti”: Nelly (Marie-Christine Barrault) e Francis (Guy Marchand)

Agnès Jaoui è Ariel

Antoine (Laurent Lafitte, a sinistra) con Adar (Bruno Putzulu)

Può nascere un amore imprevisto tra Gérard (Benjamin Biolay) e Ariel (Agnès Jaoui)…
Dedicato a tre sorelle, Valérie, Frédérique e Agathe. Per parlare di tre fratelli. Il film è L’arte della fuga (nelle sale dal 31 maggio, durata 98’), la dedica è del regista Brice Cauvin, 52enne francese di Lille, attore, regista e sceneggiatore. Anche adattatore, come mostra con intraprendenza in questa sua opera seconda trasferendo al cinema un romanzo dell’americano Stephen McCauley. Sentimenti in primo piano e piacevoli vibrazioni nei dialoghi, molto semplici ma efficaci ed eleganti a sostenere un racconto mobilitato più sui personaggi che sull’azione: senza, con questo, rammollire gli spessori dell’intensità e delle emozioni.
Le geometrie di un apparente disordine relazionale
Accenti e armonie narrative che si riflettono sulla vita di Antoine (Laurent Lafitte), Louis (Nicolas Bedos) e Gérard (Benjamin Biolay), cioè i tre fratelli che guidano, non da soli, il gioco del film. Perché al loro fianco fra amanti, fidanzati/e, amici e genitori s’affolla un ondeggiante ensemble di persone in apparente disordine relazionale o addirittura in posizione conflittuale. Non è del tutto vero, naturalmente: c’è differenza tra la scorza della storia e i modi coi quali viene escogitata. Altro che scompiglio. Le geometrie sono quasi perfette, il gioco di rimandi e di rimbalzi segue le logiche di una sceneggiatura (scritta da Cauvin con Raphaëlle Desplechin-Valbrune) molto attenta alle corrispondenze di uno schema riconducibile alla buona commedia sentimentale.
A ciascuno i suoi dubbi e le sue ossessioni
E difatti. La commedia è gradevole nel suo andare sereno tra Parigi e Bruxelles nonostante i guai e gli affanni dei suoi personaggi. Pensare che il racconto si apre col pianto di Antoine che convive con Adar (Bruno Putzulu) ma s’è appena ritrovato con la fisicità un po’ selvatica di Alexis (Arthur Igual); Louis invece s’è promesso in sposo alla paziente dolce Julie (Élodie Frégé) cui lo legano ben dieci anni di fidanzamento ma nel frattempo s’innamora perdutamente di Mathilde (Irène Jacob) e della sua calda leggerezza; Gérard, infine, tanto per sparigliare le carte si ostina follemente ad aspettare il ritorno di sua moglie Hélène (Judith El Zein) che non solo lo ha scaricato ma ha pure chiesto il divorzio, ossessione alla quale sembra di poter ovviare nel promettente incontro con Ariel (Agnès Jaoui).
Sui figli l’occhio (troppo) vigile di mamma e papà
Su questi tre sventurati, poi, aleggia vigile e in un certo minaccioso l’occhio dei genitori Nelly (Marie-Christine Barrault) e Francis (Guy Marchand) cristallizzati sul rifiuto di ogni mutamento, anche e soprattutto sentimentale, nella vita dei figli e logicamente nella loro, in questo rappresentando, all’interno della vicenda, un simbolo di solidità, d’inerzia, di resistenza al tempo, di reciproca e rassegnata indulgenza. Al cospetto del quale vien quasi voglia di rivalutare l’incoercibile vocazione dei tre fratelli super-smarriti (e certo fiaccati dalle esuberanze precettive di mamma e papà) al flirt più estemporaneo. E alla fuga, da intendersi più come necessità che come arte.
Il segno collettivo di una recitazione esemplare
Tutto questo, concentrato a tal segno sulle teste dei personaggi, da proporre una recitazione esemplare in tutte le componenti del film, dunque nella sua collettività. Ovviamente con maggiori e diversificate sfumature in Lafitte, Bedos e, in parte, Biolay; ma con autentici lampi espressivi in Jaoui e nei due genitori Barrault e Marchand che curiosamente, riavvolgendo il nastro delle impressioni, lasciano più persistente memoria di sé.