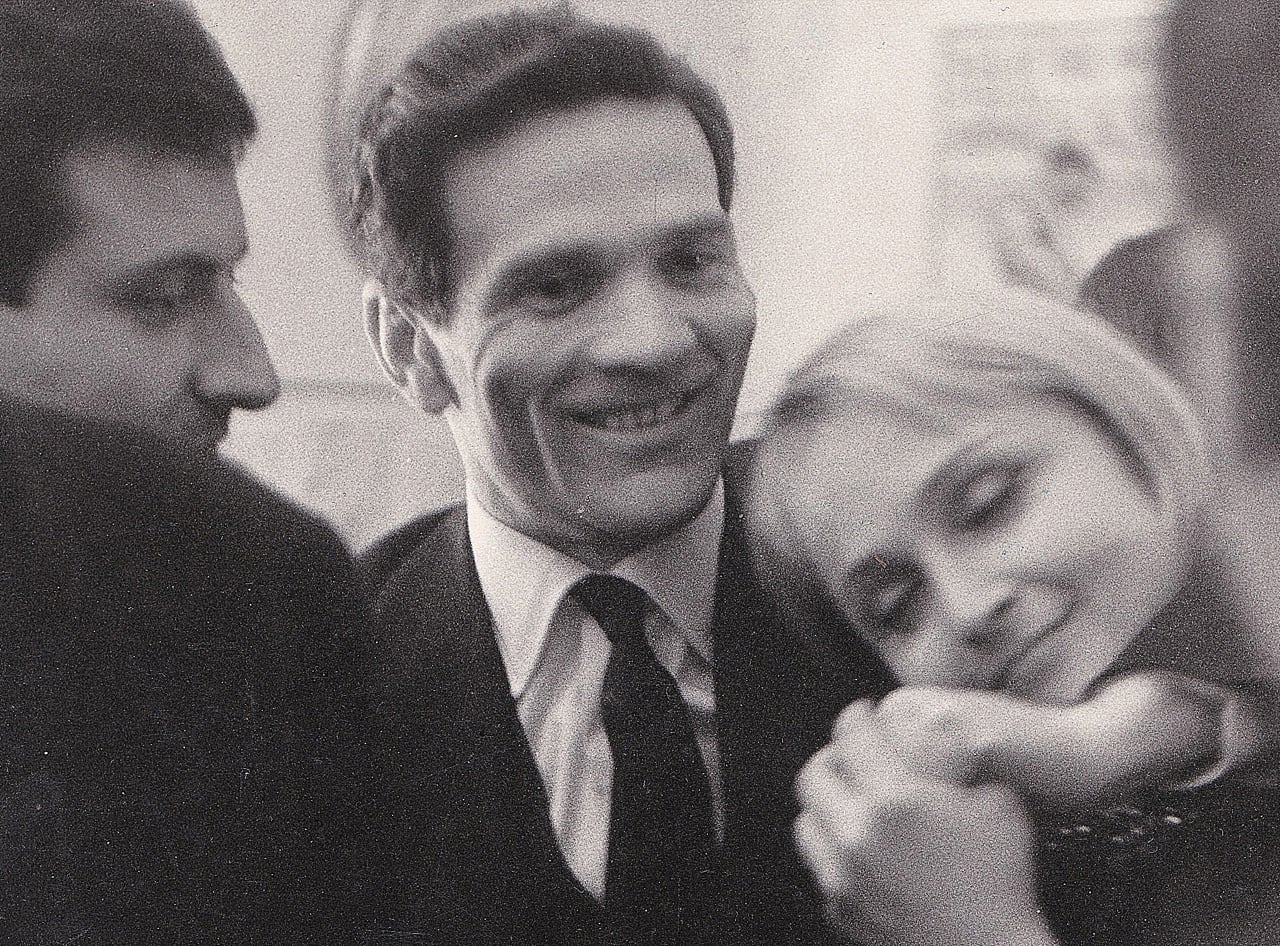Scrittori come Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Italo Calvino che collaborano con cantautori e musicisti. Una mostra ricca di testimonianze originali ripercorre gli anni Sessanta e Settanta, quando la cultura trova una cifra popolare.
Da molti anni pensavo, e l’ho anche scritto, che la poesia del Novecento si era andata lentamente spegnendo, ma non se n’era perduta, e non se ne può perdere, la necessità. Non finisce la poesia, come non finisce la pittura, come non finisce la musica, perché esse sono esigenze degli uomini, attive e passive. L’uomo ha bisogno di essa, ed essa si deve continuamente ricreare. Occorre capire dove sta e chi la fa.
Leggendo i poeti del Novecento, dopo D’Annunzio e dopo Gozzano, la mia sensazione era che quelli che ci cantano dentro, coloro di cui ricordiamo i versi, si fossero esauriti nella prima metà del secolo, con poche code: Campana, Onofri, Saba, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, forse anche Sbarbaro, giù giù, con voci sempre più rarefatte, fino a Pavese (soprattutto da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi), a Delfini, a Tobino, a Sinisgalli, a Penna (lui più di tutti).
Superata quella barriera, ancora qualche segnale viene da J. Rodolfo Wilcock e, nelle loro lingue riparate, da Biagio Marin, Giacomo Noventa, Tonino Guerra, Raffaello Baldini.
Ne ho indicato più di quanti avrei pensato, ma arrivando con fatica a superare la soglia degli anni Sessanta, come se un’improvvisa impotenza, o un linguaggio oscuro e cifrato, impedisse a molti poeti di parlare per tutti, di scrivere versi memorabili da mandare a memoria, che rimanessero come un sentimento condiviso, partecipato.
Invece mi accorgevo che i «poeti laureati» si inerpicavano lungo sentieri sempre più impervi, con parole ricercate ed emozioni inaridite, desiderosi di sorprendere o cercare linguaggi misteriosi dentro cui nascondersi e attraverso i quali sorprendere. Lo aveva ben detto Montale: «Ascoltami, i poeti laureati / si muovono soltanto fra le piante / dai nomi poco usati: bossi, ligustri o acanti».
Aveva anche indicato le ragioni della sua ispirazione segreta e riuscita: «Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi / fossi, dove in pozzanghere / mezzo seccate agguantano i ragazzi / qualche sparuta anguilla». Una sorprendente consapevolezza e la coscienza di parlare senza codici, senza linguaggi cifrati, superando i compiacimenti dell’estetismo e dell’ermetismo, con la consapevolezza di un mistero che in lui, come in De Chirico, come in Eliot, sta dietro alle cose: «Vedi in questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo segreto / talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da disbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità».
Dopo il travaglio di una più aspra ricerca linguistica, nella terza sua raccolta perigliosa, La bufera (1956), più di ogni altra cifrata e oscura, Montale avverte il rischio, e ha la necessità di tornare a un linguaggio chiaro, che lo porta alle pagine decantate e disincantate di Satura (1971), in particolare la sezione Xenia: «Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale / e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. / Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. / Il mio dura tutt’ora, né più mi occorrono / le coincidenze, le prenotazioni, / le trappole, gli scorni, di chi crede /che la realtà sia quella che si vede. / Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio / non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. / Con te le ho scese perché sapevo / che di noi due / le sole vere pupille, / sebbene tanto offuscate,/ erano le tue».
Sono forse gli ultimi versi memorabili di un’età difficile, più che un’età dell’ansia, dove i poeti della generazione successiva a quella di Montale (che era nato nel 1896) si erano in diversi modi applicati a un linguaggio incomunicante, concettoso, forse anche denso di significati, per pochi, e certamente dai ritmi non orecchiabili. I poeti ermetici della seconda generazione, Piero Bigongiari, Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Silvio Ramat, e anche quelli più narrativi, in circoli ristretti amati e ammirati, come Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni, Andrea Zanzotto, si muovevano nelle ragnatele di un linguaggio sperimentale o prosastico, lontano dalla musica della poesia. Non si escludono lampi occasionali e qualche buon esito. Ma certamente mai popolari.
La loro ricerca si era alla fine ristretta a un gruppo di affezionati, quasi sempre autoreferenziali e senza nessuna speranza di creare composizioni capaci di intercettare un sentire comune. Ma questa loro improvvisa e incomprimibile aridità, come un circolo vizioso, qualcosa da cui risulta impossibile uscire, non corrispondeva a una compressione o diminuzione della domanda, perché la sete di poesia nell’uomo è incoercibile, sconfinata. Così ho pensato che quei versi come: «M’illumino d’immenso», «Ed è subito sera», «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie», «Lenta e rosata, sale su dal mare, / la sera di Liguria, perdizione / di cuori amanti e di cose lontane», «ho parlato a una capra / Era sola sul prato, era legata», erano irripetibili, non avevano comunque trovato altri terreni fertili.
Eppure, a partire dai primi anni Sessanta, se non prima, si erano generati, con un’incredibile forza di penetrazione, versi in musica, prepotentemente necessari e impressi nella nostra memoria. Erano le parole dei nostri cosiddetti cantautori, nelle canzonette che, come colonne sonore, hanno accompagnato momenti importanti della nostra vita, soprattutto per la mia generazione.
Di colpo, nella totale distanza e incomunicabilità della contemporanea poesia, gli autori delle «canzonette» assolvevano le funzioni dei poeti, in una straordinaria, ma compiuta, supplenza. Un patrimonio di parole semplici, icastiche, indimenticabili, talvolta banali, penetrava dentro di noi, restituendoci tutto quello che la poesia ufficiale non era in grado di darci, inerpicandosi nel linguaggio insidioso che avrebbe trovato nei Novissimi e nel Gruppo 63 i suoi spericolati testimoni. In quelli stessi anni si iniziano a muovere, a partire da Domenico Modugno, cantanti di successo, con testi di straordinaria intensità: Sergio Endrigo, Gino Paoli, Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Tony Renis, Adriano Celentano, Rita Pavone, Don Backy, Edoardo Vianello, Ornella Vanoni, Mina, Iva Zanicchi, Fred Bongusto, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Gigliola Cinquetti, Patty Pravo, Lucio Dalla.
L’occupazione dello spazio è totale.Per i poeti ufficiali non ci sono margini, se non con rarissime eccezioni: non accade lo stesso in Francia, dove Jacques Prévert, Boris Vian, Jacques Brel proprio in quegli anni convivono e sopravvivono, con testi per musica che sono vivi e immediati. In Italia la supplenza dei cantautori è compiuta, assoluta e totale.
Queste e altre considerazioni si riaffacciano nella mia mente come reazione a una formidabile mostra allestita nel Castello di Santa Severa, da due appassionati e irriducibili «intendenti» di poesia contemporanea, Giuseppe Garrera e Igor Patruno, dal titolo stupito e didascalico: Tu parlavi una lingua meravigliosa: quando la canzonetta divenne poesia.
I due curatori sembrano credere al primato dei poeti, e ricordano testi di Calvino, di Fortini, di Pasolini, di Roversi, di Moravia, come se da loro potesse derivare il successo (meglio, l’insuccesso) delle canzoni, che si affermano invece tanto più quanto più sono distanti da fonti e testi alti. In realtà, la canzone sostituirà la poesia, sostanzialmente inaridita, costante espressione di un linguaggio consunto e indecifrabile.
Restano commoventi, oltre alle voci dall’aldilà, che ti fermano nelle sale, i riferimenti al Valzer della toppa (Pasolini/Gabriella Ferri), e i richiami, sempre alti, a Ignazio Buttitta e a Biagio Marin, con tutto il tributo di ammirazione per il versatile e cerimonioso Sergio Endrigo, sempre in coppia con l’infaticabile e irriducibile Pasolini, per il non fortunatissimo Il soldato di Napoleone (1962), presentato dall’indimenticabile Gaio Fratini. Con questo incipit: «Dalla malinconia all’invettiva, dal paradosso al nonsense: lo stile di Sergio Endrigo non si presta a comode catalogazioni, così vivo, ingenuo, vario, instabile, incline sempre all’avventura».
Intanto, a Sanremo, spopola la coppia Domenico Modugno e Claudio Villa. Tony Renis canta Quando quando quando, e vince nel 1963 con Uno per tutte. Nello stesso anno, il poeta Mario Luzi pubblica la raccolta Nel Magma. Per pochissimi…