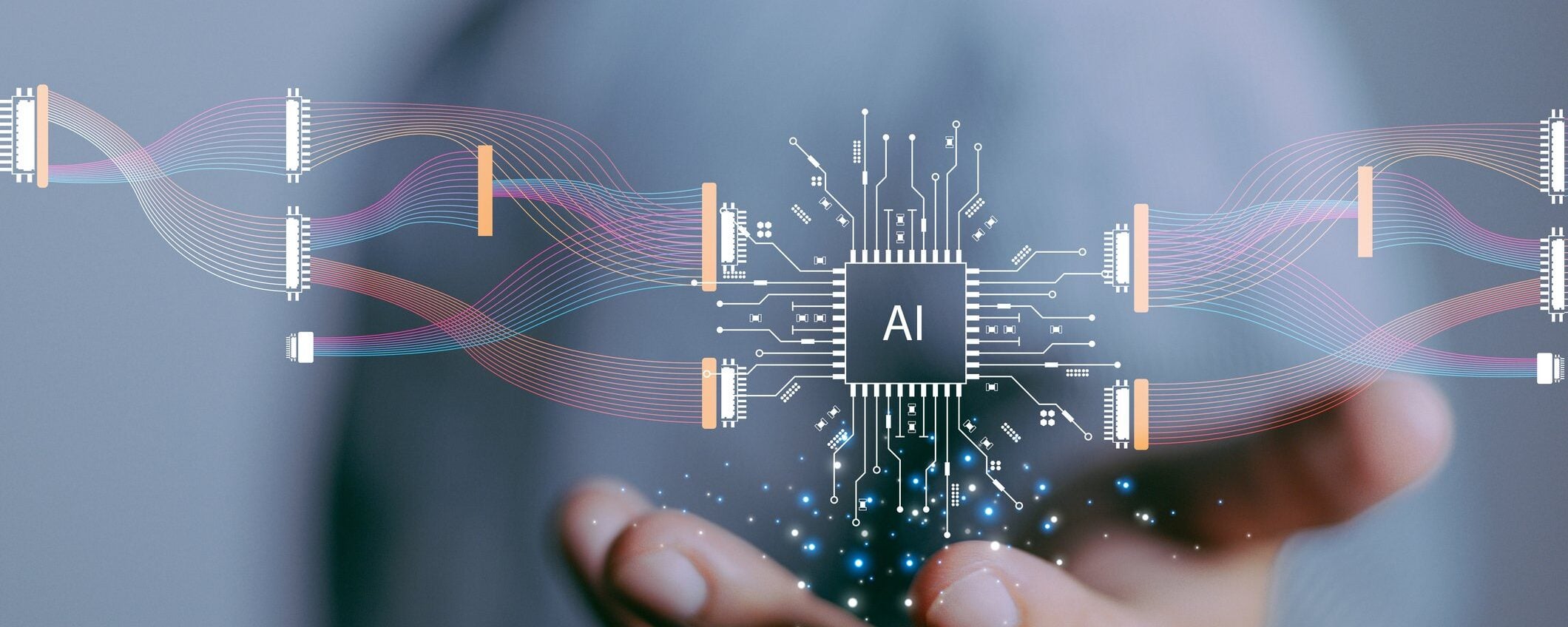È appena uscito un libro che analizza il nostro rapporto con la tecno-intelligenza sempre più al centro del mondo. E di questa, filosoficamente, individua i limiti.
Nei documenti della Chiesa cattolica che si occupano della dottrina sociale ricorre, di fronte alle innovazioni tecnologiche umane, da sempre, il solito ragionamento, secco e breve: la tecnologia in sé non è né un bene né un male, dipende dall’uso che l’uomo ne fa. È così anche per l’Intelligenza artificiale (Ia). Essa attrae per ciò che riesce già a fare e impaurisce per ciò che potrebbe arrivare a fare. Nel mezzo ci sta l’uomo che è soggetto ma che potrebbe diventare, in modo degenerato, oggetto della stessa Ia. Sui rischi cui facciamo cenno hanno scritto un bel libro, un libro, come direbbe Niccolò Machiavelli ne Il principe, «utile», Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, Umano, poco umano. Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale (Piemme). I due autori fanno anzitutto un’opera di scandaglio all’interno della Ia per informare il lettore sulle mete già raggiunte, per esempio nelle scienze, in particolare in medicina, ma anche in Borsa, e il fenomeno particolare di editori che sostituiscono giornalisti professionisti con i software creativi e intelligenti di ultima generazione. Dunque, si parla di una estensione e di una possibile ulteriore pervasione, se non invasione, della Ia in molti campi della vita sociale.
Nello scrivere questo libro si sono uniti due personaggi che si occupano di cose diverse. Mauro Crippa dirige l’informazione e la comunicazione di Mediaset pur essendo uno studioso di filosofia. Giuseppe Girgenti è uno studioso di filosofia antica e la insegna presso l’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano. Quindi si sono unite in questo libro, diciamo, due visioni dello stesso tema che potremmo definire una sorta di consapevolezza da dentro il sistema rappresentato da Crippa e una visione umanistica di ciò che sta accadendo di Girgenti. Naturalmente, in questi casi non c’è una delimitazione netta tra i due soggetti, tra i due autori, altrimenti il libro verrebbe fuori come un «patchwork» senza senso. Cosa che questo libro non è, anzi, è un lavoro che fa continue incursioni avanti e indietro tra la filosofia antica e la realtà tecnologica odierna. Ma qual è, alla fine, la ricetta che i due autori propongono? È una ricetta antica che è stata ripetuta lungo la storia del pensiero sotto varie forme e varie angolature: dalla filosofia antica fino alla sua fase ellenistica, poi fino al Medioevo nelle sue sfaccettature e poi dalla filosofia moderna con il «cogito» cartesiano fino alla filosofia esistenzialista del Novecento, solo per fare alcuni esempi. Prendiamo, per esempio, l’idea di Carlo Magno di affidare ad Alcuino di York, come suo consigliere, la riforma degli studi in senso umanistico per recuperare l’Humanum attraverso la creazione delle scuole palatine. Volendola dire in modo sistematico, si può affermare che Crippa e Girgenti suggeriscono che per fare un passo in avanti occorre farne alcuni indietro: per prevenire ma anche curare le possibili degenerazioni dell’Humanum, operate dalla tecnologia, occorre ritornare alle massime espressioni dell’Humanum stesso così come sviluppato teoricamente nella lunga storia del pensiero umano. Alla degenerazione dell’uomo, attraverso un uso improprio della tecnologia – come ricordano i testi teologici della Chiesa – si può opporre esclusivamente una concezione dell’uomo che sia ben più ampia e profonda di quella che viene fuori dalla Ia.
La Ia non sa di essere la Ia, come gli animali non sanno di essere animali. Il cane non sa di essere un cane, segue il suo istinto naturale insito in sé stesso dalla natura. L’uomo è l’unico essere sulla Terra che sa di essere uomo. Cioè che ha l’autocoscienza, la coscienza di sé stesso. Perché questo elemento è così importante? Perché pone l’esistenza della Ia e l’esistenza dell’uomo su due piani del tutto diversi, dove il piano dell’uomo è irraggiungibile per la Ia. È l’uomo che costruisce, crea, inventa la Ia ed essa agisce all’interno del perimetro che l’uomo le assegna.
È pensabile che la Ia., non essendo cosciente di sé stessa, possa avere un’intuizione creativa come succede nel caso dell’uomo, dell’artista, del filosofo, dell’imprenditore? La risposta che emerge da questo libro è negativa. O meglio, vi sono descritti i possibili effetti perversi – oltre a quelli apprezzabili – dello sviluppo di questa tecnologia, ma accanto a essi sono descritte le paure e i timori di qualcosa che l’uomo ha fatto e del quale teme uno sviluppo autonomo che possa andare contro sé stesso. Il libro si intitola Umano, poco umano. Quel «poco» mi suggerisce una netta diversità di livelli tra l’umano e l’artificiale ma anche l’irraggiungibilità dell’artificiale nei confronti dell’umano. Ci sono di mezzo barriere piuttosto alte e spesse di secoli che sono l’io, l’autocoscienza, la coscienza di sé, le capacità di intuizioni creative che superano, talora, ciò che ci sembrerebbe impossibile a noi uomini superare, e cioè il ragionamento razionale. Tutto questo, a oggi, e per fortuna, non è superabile. Questo libro mi pare che intelligentemente lo escluda.