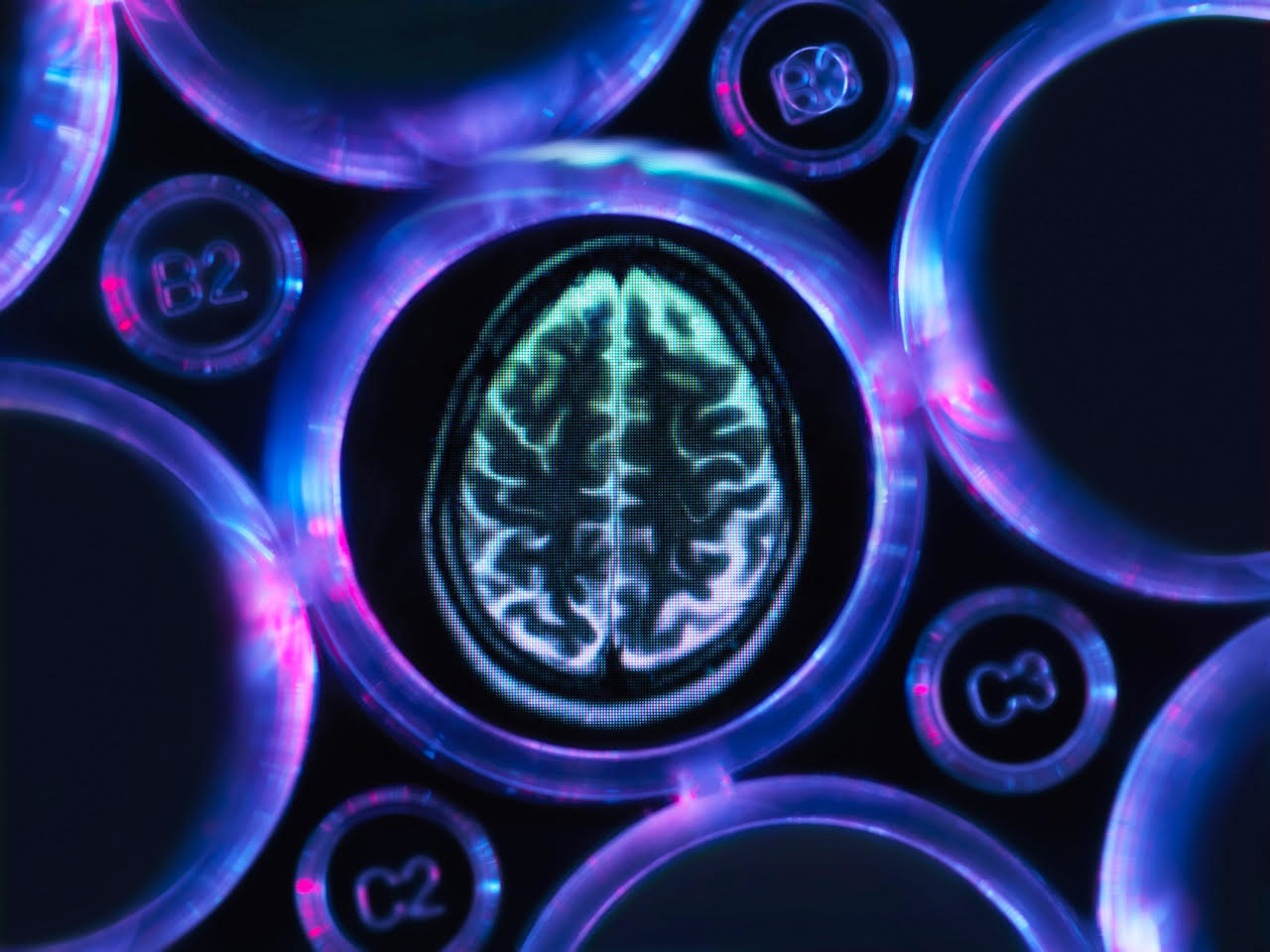Adriano Aguzzi è neurobiologo ed esperto mondiale di prioni, proteine infettive coinvolte nelle demenze. Nel suo laboratorio a Zurigo ha intrapreso una sfida titanica: testare il ruolo di ogni singolo gene del nostro Dna sull’innesco delle malattie del cervello.
Ricordate, a fine anni Ottanta, il morbo della mucca pazza e la sua variante che colpiva gli esseri umani, la malattia di Creutzfeldt-Jakob? La patologia (nome scientifico, encefalopatia spongiforme bovina, Bse, nell’uomo veniva trasmessa da carne infetta) distruggeva il cervello in pochi mesi trasformandolo in una specie di spugna e portava a una morte orribile. A causarla erano i prioni, proteine alterate che si «piegavano» in maniera anomala e con un comportamento allora assai misterioso. Privi di Dna o Rna, riuscivano a infettare le cellule cerebrali pur non essendo né batteri né virus: per semplicare, si replicavano facendo copie di se stessi e inducendo altre proteine a deformarsi nello stesso modo.
L’epidemia di Bse (originata da farine animali contaminate, oggi bandite) seminò il panico e terminò, fortunatamente, nel giro di qualche anno. Ma la ricerca su queste proteine infettive è andata avanti, soprattutto nel laboratorio di uno dei maggiori esperti mondiali di prioni: il neurobiologo Adriano Aguzzi, direttore dell’Istituto di neuropatologia all’Università di Zurigo, che ha ricevuto di recente un importante riconoscimento internazionale, l’Ottorino Rossi Award della Fondazione Mondino di Pavia.
Negli ultimi anni, gli studi condotti dal gruppo di Aguzzi hanno dimostrato che i prioni sono coinvolti non solo in quella di Creutzfeldt-Jakob, ma anche in altre patologie neurodegenerative estremamente più comuni, come l’Alzheimer e il morbo di Parkinson. Il traguardo finale di questi studi è, potenzialmente, molto promettente: individuare i meccanismi di base con cui i prioni agiscono nelle malattie neurodegenerative potrebbe aprire la strada a trattamenti più efficaci di quelli attualmente disponibili.
Per il morbo di Alzheimer, per esempio, il panorama terapeutico è sconsolante: i pochi farmaci a disposizione non frenano (al massimo rallentano di pochi mesi) l’avanzare della malattia che, come una colava lavica, frantuma memorie, capacità cognitive, identità personale.
«Il problema è che di tutte queste proteine prioniche coinvolte nella neurodegenerazione, come la tau, la sinucleina, non disponiamo della struttura fine, tridimensionale, ad alta risoluzione» premette Aguzzi. «Alcune delle loro proprietà fisico-chimiche si possono dedurre, ma la struttura fine 3d è indispensabile per ottenere terapie altamente specifiche. È, questa, una sfida tecnologica e biologica non ancora vinta». Quindi, niente progressi a breve termine? Aguzzi, che è un ricercatore assai testardo, sulle demenze ha aperto negli ultimi anni un nuovo fronte di ricerca. Nel suo laboratorio, che raggruppa una trentina di scienziati di cui metà italiani («sono bravi, sarebbe meglio se stessero in Italia ma siccome lì è difficile fare ricerca, li ho presi io»), l’altro focus fondamentale è capire in che modo esattamente le proteine prioniche che si accumulano nel cervello danneggiano il sistema nervoso producendo i sintomi delle demenza. «Nell’Alzheimer e nel Parkinson queste proteine patologiche si aggregano» spiega Aguzzi. «Ma che cos’è che le attiva?».
La teoria classica è che i primi passi verso la demenza siano le placche della proteina beta-amiloide, dette anche placche senili. Oggi però molti ricercatori si chiedono se la betamiloide sia davvero la causa e non, piuttosto, la conseguenza della malattia in fase avanzata. «Senza dubbio c’entrano, ma non sono tutta la storia. Hanno un ruolo anche le cellule immunitarie del cervello, i microglia, che si attivano in maniera abnorme producendo sostanze neurotossiche che danneggiano le funzioni cognitive».
Per fare luce su questi meccanismi cerebrali tuttora oscuri, Aguzzi ha una strategia estremamente ambiziosa: verificare quale può essere il ruolo di tutti i geni del nostro Dna sull’innesco delle malattie neurodegenerative. «Siamo in un ambito nuovo, in cui dobbiamo ammettere di non avere alcuna idea di cosa sta succedendo» dice lo scienziato. «L’unica maniera per venirne a capo, quindi, è testare l’influsso di ciascun gene sul processo di neurodegenerazione. E visto che di geni ne abbiamo circa 20 mila, stiamo facendo 20 mila esperimenti con ogni singolo gene finché non troviamo quello, o quelli, giusti». In altre parole, i geni che, se vengono inattivati, prevengono la demenza senile.
Ventimila esperimenti con 20 mila geni è impresa titanica. «Vero, è la missione più impegnativa che abbia mai intrapreso in trent’anni di carriera. Ma ho la fortuna di avere i mezzi, le strutture e le persone per poterlo fare, e lo ritengo un imperativo morale. Ci stiamo lavorando ogni giorno da tre anni, con la robotica, l’automazione e l’intelligenza artificiale, penso che potremo concludere la sfida nel giro di un paio d’anni».
La prospettiva è entusiasmante (anche se nel campo dell’Alzheimer il passato insegna una certa cautela): una volta individuati i geni che hanno un ruolo chiave, si potranno forse mettere a punto molecole e composti che funzionino. Farmaci che finalmente dimostrino di poter arrestare la devastazione delle demenze senili. «Abbiamo macchinari che ci permettono di testare 40 mila reazioni in 24 ore. Sono ottimista. Certo, io lavoro sui meccanismi fondamentali, spetterà poi ad altri mettere a punto terapie efficaci».
A oggi, l’ultimo farmaco approvato dalla Fda americana contro l’Alzheimer (la memantina) risale a circa 17 anni fa. Di recente colossi farmaceutici come Merck e Pfizer hanno rinunciato ala ricerca, non intravedendo più alcun mercato remunerativo. Chissà, potrebbero tornare in pista avendo, come target, proprio i geni identificati nel laboratorio di Zurigo.
NUOVE SPERANZE: il litio potrebbe fermare l’Alzheimer
L’utilizzo del litio (farmaco impiegato nella depressione bipolare) contro l’Alzheimer è sempre stato controverso: difficile valutarne la reale efficacia (troppa differenza nelle dosi e nei trattamenti), e gli effetti collaterali nel lungo termine sono pesanti. Un nuovo studio, però, condotto da ricercatori della McGill University, sembra cambiare le cose: somministrato su topi transgenici (che replicano il modello umano di Alzheimer), in una formulazione che ne facilita il passaggio al cervello a dosi 400 volte inferiori rispetto quelle prescritte per i disturbi dell’umore, il litio pare in grado di contrastare le placche cerebrali e di rallentare il declino cognitivo. Prossimo passo: avviare test clinici su pazienti nelle prime fasi di Alzheimer o ad alto rischio di ammalarsi.
Cosa possiamo fare per non ammalarci
Se è vero (e purtroppo lo è) che al momento non esistono cure efficaci contro l’Alzheimer, qualcosa possiamo concretamente fare per allontanare il rischio di ammalarci e per proteggere il cervello. Lo indicano due nuovi studi, uno apparso sul sito online della rivista Neurology («Dietary flavonols and risk of Alzheimer dementia»), l’altro pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition, e riguardano entrambi l’alimentazione. La prima ricerca, del 29 gennaio scorso, è stata condotta alla Rush University di Chicago su 921 persone con età media 81 anni, seguiti per sei anni. In questo periodo di tempo, 220 dei partecipanti hanno poi sviluppato i sintomi della malattia. In base ai risultati, si è visto coloro che consumavano quotidianamente cibi o bevande (come il té verde) ricchi di antiossidanti e flavonoidi, per un totale di circa 15,3 milligrammi al giorno di queste sostanze fitochimiche, avevano una riduzione di circa il 48 per cento del rischio di sviluppare Alzheimer. Più esposti erano invece gli anziani il cui consumo di antiossidanti e flavonoidi si aggirava intorno a 5,3 milligrammi al giorno.Per dirla con altri numeri: su 186 persone con il consumo più elevato di antiossidanti, si sono ammalati in 28 (15 per cento); in quelli con il consumo più basso, 54 su 182 sono stati colpiti dall’Alzheimer (30 per cento).Adesso, se volete sapere quali sono i cibi più ricchi di flavoinoidi e antiossidanti, ecco quelli indicati dai ricercatori di Neurology studio: mele, pere, olio di oliva, pomodori, vino, fagioli, broccoli, spinaci, tè, arance.Il secondo studio, che ha riguardato 640 anziani di Loma Linda, in California, seguiti per due anni, cita invece le noci: mangiare questo tipo di frutta secca, ricca di acidi grassi omega 3 e polifenoli, può contribuire a rallentare il declino cognitivo nei soggetti a rischio. In che modo lo fanno? Entrambi contrastano lo stress ossidativo cellulare e l’infiammazione, due fattori negativi per il cervello. In più le noci (circa tre al giorno) riescono anche ad abbassare i livelli di colesterolo «cattivo», l’Ldl, aiutando così anche la salute del cuore e del sistema cardiocircolatorio.