Attore, cantante, musicista e ora anche scrittore. È appena uscito con il libro HappyNext dove racconta come trovare la pace interiore e vivere bene. Un viaggio tra interviste a monaci, filosofi, poetesse insieme a una sua personale visione: «Per raccogliere serenità» racconta a Panorama «bisogna trasformarsi in un soffione che nel vento lancia i suoi semi. Senza sapere se germoglieranno».
La felicità deriva da calma e distacco scrive lo Zhuang-Zi, il testo fondamentale del taoismo (e uno dei cinque libri da tenere sul comodino). Facile a dirsi, ma molto difficile da realizzare. In questo tempo dove l’incertezza ci aggroviglia le budella, pochi riescono a essere distaccati, tanto meno calmi. Simone Cristicchi questo lo sa. Da due anni ha iniziato un viaggio personale alla ricerca della felicità, intervistando filosofi, registi, maestri zen, suore di clausure, monaci dalle lunghe barbe, poetesse e scrittori. Per arrivare alla conclusione che ha un senso diverso per ognuno di noi. Il cantautore, scrittore e talentuoso attore di teatro racconta a Panorama questo percorso, che è diventato un libro HappyNext (La Nave di Teseo) e sarà anche un film e uno spettacolo teatrale.
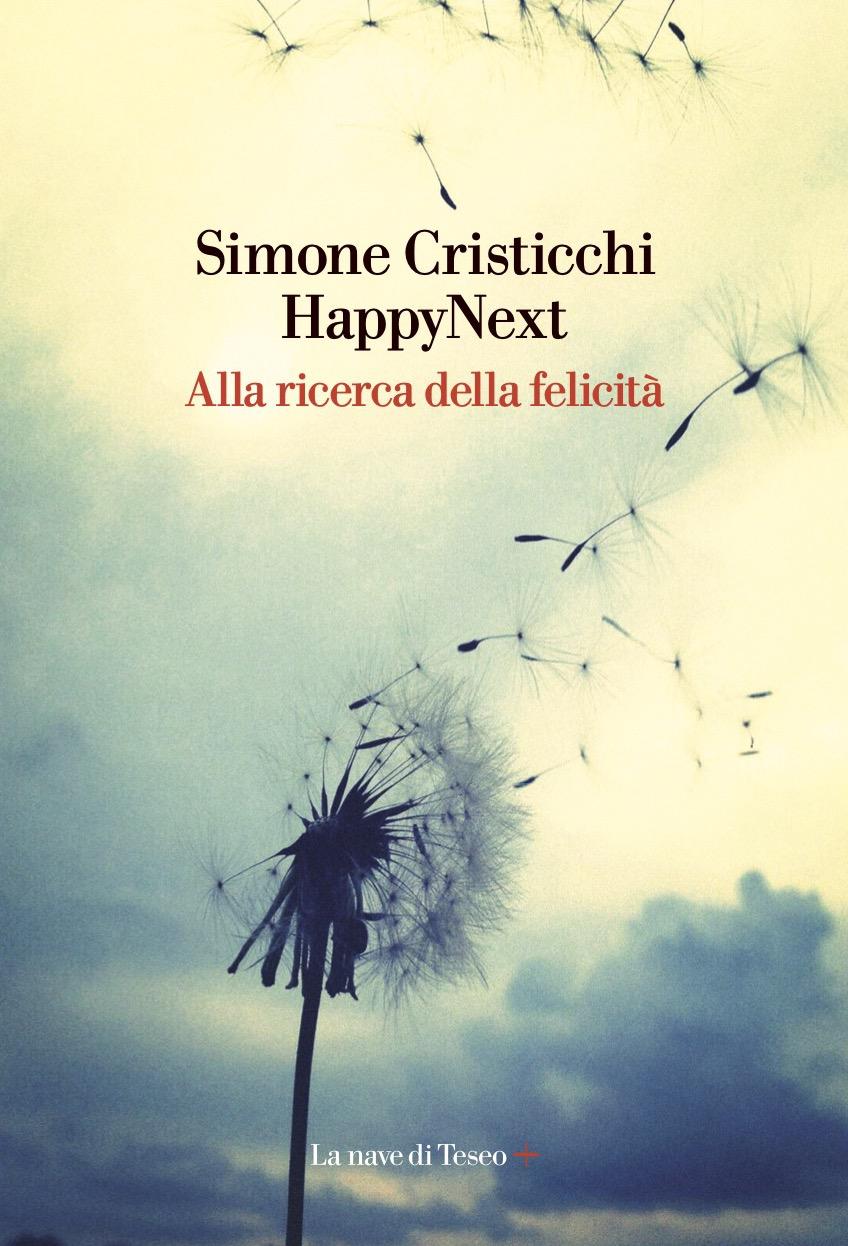
In Francia i teatri sono stati occupati dai giovani. A Mosul il teatro distrutto dall’Isis ha riaperto con un commovente concerto.
Da noi invece solo un assordante silenzio, perché?
«Nel nostro Paese c’è un esasperato individualismo. Ognuno pensa al proprio orticello. Non c’è coesione. La pandemia ha messo a nudo problemi che esistevano da sempre. Servono meno ego e più rapporti di fiducia».
Cosa l’ha spinta ad andare alla ricerca della felicità?
«È coinciso con un cambiamento del mio modo di vivere. Non è stata una conversione, ma dopo anni passati a occuparmi di fatti storici ho sentito la necessità di avventurarmi nel mondo dell’invisibile. E così ho fatto un’esperienza in un eremo a Campello sul Clitunno. Un’immersione nel modus vivendi delle sorelle francescane».
Come è stato?
«Ho vissuto una settimana in una celletta spartana: un letto, una candela, un lavabo e nient’altro. Non c’era niente e c’era tutto. E in quel silenzio assoluto, come un eremita, ho provato grandi emozioni».
Lei è credente?
«Sono sempre stato scettico, ma curioso. Più che credente, sono un cercatore. Oggi mi piace studiare la matrice universale che unisce le religioni. Il fiume sotterraneo che collega le varie liturgie. Per esempio, non conoscevo l’esistenza della meditazione cristiana, di cui ci sarebbe tanto bisogno».
Alle persone che ha incontrato ha fatto tre domande. Ora le poniamo a lei: qual è il male che ci impedisce di essere felici?
«L’individualismo, l’egoismo, la disattenzione sono la peste di quest’epoca. Si ascolta poco l’altro. Kierkegaard scrisse: “La felicità è una porta che si apre solo verso l’esterno”. Eppure quando facciamo qualcosa insieme ci dà soddisfazione, come impastare il pane con i nostri figli durante il lockdown. Per me la metafora perfetta è un’orchestra sinfonica, dove ognuno mette la sua nota e tutti sono al servizio della musica».
È difficile suonare insieme?
«Essere “noi” è difficile. Sembriamo sempre collegati, connessi, eppure noto uno scollamento dalla realtà. I social hanno cambiato regole e abitudini. C’è una solitudine straziante. Abbiamo il culto dell’infelicità».
Allora cos’è la felicità?
«Per me è il fiore di tarassaco con i semi che volano nel vento che ho voluto sulla copertina. La vera felicità è gettare dei semi, senza sapere se germoglieranno. La soddisfazione è spendersi per gli altri. A volte sono riuscito a vedere crescere le mie azioni positive. Ma dobbiamo ricordarci che per seminare bisogna prima dissodare la terra. È una fatica che dobbiamo fare tutti, come disse la scrittrice Etty Hillesum: “Si deve cominciare da noi, ogni giorno, da capo”».
Allora per raggiungerla bisogna lavorare duro?
«Sì ed è un lavoro collettivo, che parte dalla profondità dell’essere. Se perdiamo tempo, se siamo spocchiosi sarà difficile smuovere quel terreno».
Che sensazione dà la gioia?
«Io la provo ogni volta che i miei occhi riescono ancora a stupirmi. Cerco una felicità duratura, quella che San Francesco chiamava “perfetta letizia”, uno stato che ti permette di gioire anche quando le cose non vanno come avresti voluto. È una calma interiore, che ti fa leggere le parti negative della vita come qualcosa da trasformare».
Ma il problema alla fine è uno solo. Quale?
«La nostra mente, questo strumento meraviglioso e terribile. Tutto è generato dal pensiero. Per gli orientali la felicità è un concetto sopravvalutato. Direi piuttosto equivocato. Oggi si scambia con il benessere, con un weekend alle terme».
L’ultima domanda che ha rivolto ai suoi intervistati: se esistesse una manuale cosa vorrebbe leggerci?
«Non credo alle ricette delle centinaia di volumi che spiegano come essere felici. Ognuno può costruire la ricetta personale, il suo vademecum. La cosa che mi ha colpito è che molte delle persone cui ho chiesto cos’è la felicità, sono rimasti ammutoliti. Non se lo erano mai domandati. Rimanevano interdetti come davanti a un’equazione in campo complesso. Sembra che la costruzione della felicità propria e degli altri sia l’ultimo dei pensieri».
Come cambia il punto di vista tra laici e uomini di fede?
«In fondo siamo tutti alla ricerca della stessa cosa. Attraverso forme diverse. A me affascina maggiormente l’idea che ci sia una dimensione altra, lo trovo più stimolante. Si possono dare tanti nomi: Dio, assoluto, energia universale. È stata la vita che mi ha invitato a guardare oltre le mie convinzioni di cartapesta. Basterebbe ammettere che tutto è un grande mistero».
Che posto ha il mistero più grande, la morte?
«Deve essere un pensiero costante. Purtroppo è ancora un tabù. La morte di mio padre, quando ero bambino, è stata la nascita di Simone artista. Da un immenso dolore è germogliato un seme».
Si può essere felici oggi «mentre svaniscono le astute speranze di un decennio meschino e disonesto», come diceva W.H. Auden?
«Questo è un momento propizio per ripartire dalle grandi domande. Certo c’è una buona parte che non vede l’ora di tornare al proprio inferno personale, alla routine massacrante, la loro sicurezza. Ma dovremmo provare a rivedere le nostre vite. Il mio amico Don Luigi Verdi dice che dovremmo diventare «monaci» nelle nostre metropoli. Non c’è bisogno di indossare il saio. Ma avere un’attitudine di ricerca, non accontentarsi. La pandemia potrebbe essere questo punto di svolta. Sono ottimista: c’è un voler tornare alla semplicità, all’essenza delle cose. Anche io mi sono riscoperto mezzo contadino. Mi sono preso cura del mio tempo
e non tornerò ai ritmi di prima, 120 repliche all’anno. Dopo questo lungo periodo fermo non sento la nostalgia di quella che chiamo la dipendenza dall’applauso. E ne sono felice».
L’amore almeno rende felici?
«Assolutamente. Terribile e meraviglioso insieme».

