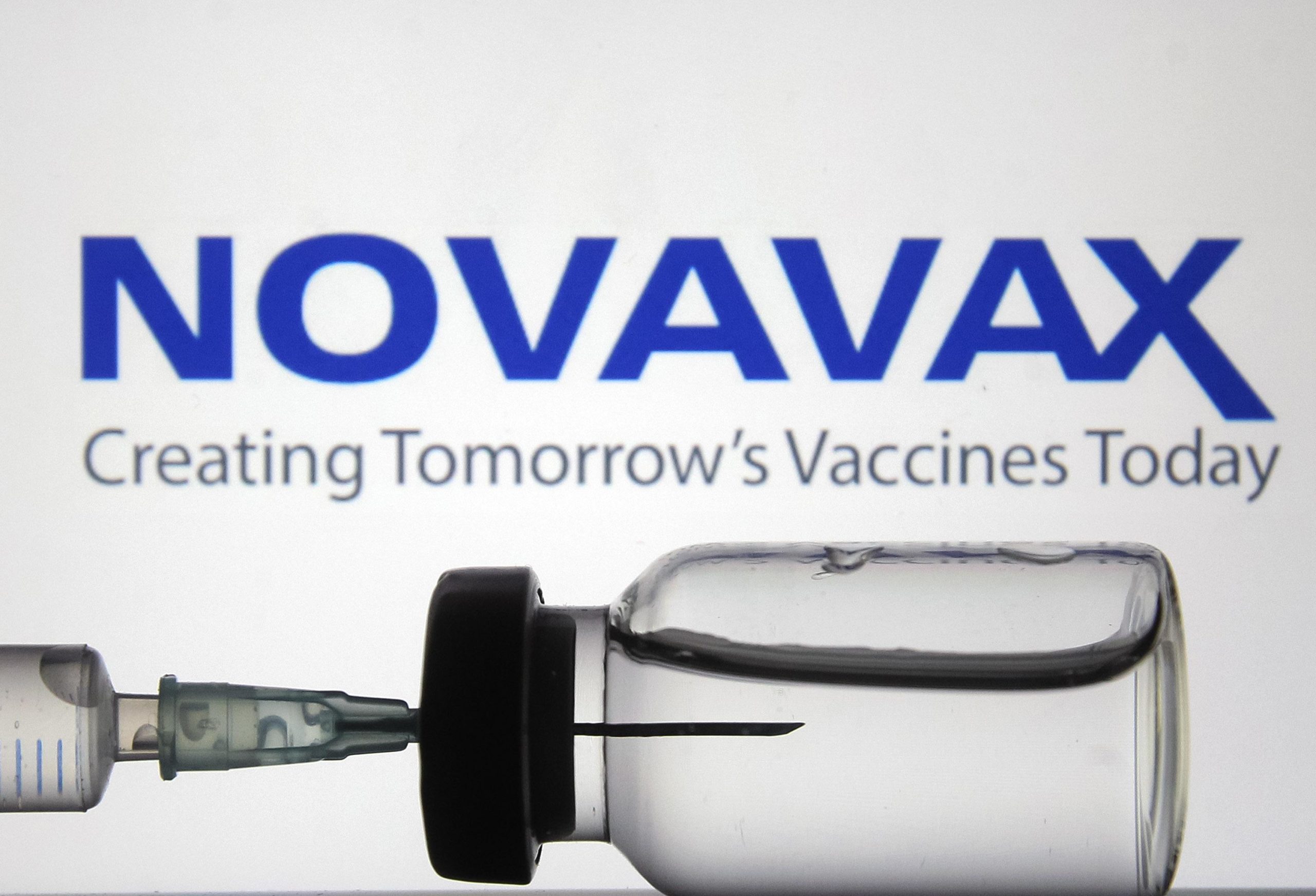Ora lo sappiamo: il punto debole della tecnologia a mRna è la durata della risposta immunitaria, inferiore alle aspettative iniziali. Intanto, arrivano due nuovi antidoti basati su metodi «tradizionali»: Nuxavoid e VLA2001, e si spera inducano anticorpi più longevi. Oltre a suscitare meno diffidenza in chi ha dubbi e timori. In attesa degli spray nasali che bloccano l’ingresso al Sars-CoV-2 fino all’iniezione contro tutti i coronavirus.
Fosse un film, la trama sarebbe lineare e il finale prevedibile: una devastante pandemia avvolge il pianeta, provoca 5 milioni di morti e oltre 230 milioni di contagi, finché nei laboratori più avanzati gli scienziati mettono a punto formidabili vaccini che stroncano il virus bastardo. Happy ending.
Al di qua dello schermo, la realtà è assai più intricata. Stessa pandemia inarrestabile, stesso numero di vittime e infetti, finché arrivano armi scientifiche di nuova concezione. Le similitudini però si fermano qui. Una parte della popolazione mondiale non vuole farsi inoculare alcunché, obietta, protesta. I vaccini sono un’ottima garanzia per non finire intubati o interrati, ma la loro efficacia contro il contagio si riduce velocemente. Dopo 3 o 4 mesi, i nostri volenterosi anticorpi indotti dall’iniezione si fanno meno numerosi e meno potenti. E il virus, un camaleonte biologico, muta e corre più veloce di prima.
In questa pandemia «dinamica», come l’ha definita un esperto, la vittoria è ancora lontana. Così, oltre ai due vaccini a Rna messaggero, che hanno finora furoreggiato negli Stati Uniti e in Europa, la scienza arruola «vecchie reclute», come i vaccini tradizionali creati con tecnologie in uso da anni. L’Ema ha appena approvato il Nuxavoid dell’azienda americana Novavax, a base di proteine ricombinanti: copie ottenute in laboratorio della spike, che il virus usa per entrare nelle cellule umane. Mentre la francese Valneva sta per lanciare il suo VLA2001, che usa il Sars-CoV-2 inattivato per stimolare le difese immunitarie. Il primo arriva in Italia entro fine gennaio, il secondo dovrebbe essere approvato nel primo trimestre 2022. Ce n’era davvero bisogno? Saranno più efficaci? Avranno meno effetti collaterali? Contro la Omicron, ce la faranno? E, visto che sono stati messi a punto in modo «tradizionale», saranno accettati più volentieri dai malfidenti? Quante domande. Andiamo con ordine.
Certo che servono. Anche oggi, il «magnifico duo» a mRna, una svolta nel campo dell’immunologia (la stessa tecnica esiste sin dai primi anni 90 in altri ambiti, per esempio in oncologia) non è l’unico a combattere il Sars-CoV-2. Il russo Sputnik è a base di due adenovirus; i cinesi Coronavac e Sinopharm, con 4 miliardi di dosi al mondo, utilizzano il coronavirus inattivato. Un unico bersaglio, insomma, e un repertorio sempre più vasto di proiettili.
«Novavax, a proteine ricombinanti, impiega una modalità già collaudata per il virus dell’epatite B o la pertosse» spiega Roberto Cauda, direttore del dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. «Di fatto la proteina inoculata per stimolare il sistema immunitario è sempre la spike, quella del ceppo originario di Wuhan. Arriva adesso rispetto a quelli a Rna perché ha richiesto più tempo per realizzarlo. Non significa che sia meglio o peggio».
Efficacia dichiarata di Novavax, dopo i trial clinici su circa 30 mila soggetti in Usa, Messico e Regno Unito: 90,4 per cento contro le forme moderate o gravi della malattia (paragonabile a quella di Pfizer e Moderna entro 4 mesi dalla seconda dose). Anche gli effetti collaterali sono un po’ sempre quelli: «Non sono legati alla tecnologia, bensì al fatto che sollecitano il sistema immunitario contro la spike. Febbre, dolori muscolari, spossatezza» precisa Cauda.
E i gravi, sia pure rari, eventi avversi collegati ai vaccini più innovativi, come i casi di sindrome di Guillain-Barré, miocardite, trombosi venosa profonda? Durante il follow-up di sicurezza (anche se piuttosto breve, un paio di mesi), non sono emersi. «La tecnologia a mRna è rapida ed efficace, però il tallone di Achille si è dimostrata la durata della risposta immunitaria» riflette Roberto Ieraci, infettivologo e responsabile scientifico delle Strategie vaccinali della Regione Lazio. «Il sogno che la pandemia fosse soffocata dai vaccini a mRna era irrealistica, vista la comparsa di varianti preoccupanti. Serve una seconda generazione di vaccini con allestimenti diversi. E poi quelli a mRna costano molto, richiedono una struttura logistica impressionante e una conservazione a temperature estremamente basse, sono poco maneggevoli per molti paesi del mondo. È in questo scenario che va valutato l’arrivo di Novavax, che contiene una sostanza coadiuvante, la saponina, per amplificare la reazione immunitaria, quindi è indicato anche per immunodepressi e anziani».
Ancora più tradizionale è il vaccino francese Valneva, che per «addestrare» il sistema immunitario utilizza lo stesso Sars-CoV-2 inattivato (o ucciso) e reso innocuo. Lo si neutralizza con il calore o con particolare sostanze chimiche, impedendogli così di replicarsi. Era così, facendo un po’ di storia, il vaccino anti-polio di Salk degli anni Cinquanta. Se iniettato, l’organismo riconosce il virus inattivato come estraneo e produce gli anticorpi protettivi.
Un potenziale vantaggio di un vaccino a virus intero, precisa Cauda, «è che dovrebbe risentire meno delle varianti: iniettando l’intero corpo virale, anche se la proteina spike muta l’organismo produce una reazione anticorpale globale, più simile a quella di chi ha avuto la malattia».
Di Valneva la Ue ha prenotato 27 milioni di dosi (in Italia 3 milioni). E fino a 100 milioni per Novavax. Entrambi potranno servire per i richiami o le prime dosi a chi finora non si è immunizzato. La loro protezione durerà di più di quella conferita dai vaccini a Rna? Sarebbe auspicabile, ma ancora non si sa. Intanto dobbiamo fare i conti con la variante Omicron (non sarà l’ultima). E nessuno degli attuali vaccini, passata una manciata di mesi, blocca il contagio.
«I vaccini anti-Covid sono stati creati a una velocità sorprendente, e la loro efficacia nei test clinici ha superato le aspettive di quasi tutti gli scienziati» scrive Science. «Ma una volta calati nel mondo reale, le cose si sono “incasinate” (got messy, ndr). Il risultato finale è stato metà un trionfo, metà un disastro».Come racconta il New York Times, mentre il 50 per cento della popolazione del pianeta ancora aspetta una dose, nel «pentolone degli scienziati» oggi bollono oltre 300 nuove formulazioni di vaccini. «Per non restare sotto scacco delle varianti, e Omicron con le 32 mutazioni è davvero incredibile, servono vaccini che oltre alla spike colpiscano altre proteine e altri target» sostiene Ieraci. «Fino al vaccino universale contro tutti i coronavirus». Al «pan coronavirus vaccine» lavorano parecchi paesi (Stati Uniti, Australia, Singapore), anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Per ora siamo nella fase di test su topi ingegnerizzati. Intanto, giusto per essere «dinamici» come la pandemia, si sta pensando anche a vaccini per via inalatoria o orale. A cambiare non sarebbe la tecnologia, quanto la sede di somministrazione. Lo spray nasale si concentrerebbe nelle vie respiratorie bloccando la prima via d’ingresso del virus.
Da poche settimane ricercatori israeliani ne stanno sperimentando uno in Sudafrica. Avrebbe il vantaggio di stimolare, oltre a una reazione generale, la risposta locale delle mucose respiratorie. Potrebbe essere dato anche per via orale, come succedeva, sempre contro la polio, con il secondo vaccino di Sabin, sciolto su una zolletta di zucchero.
Scelte future che hanno le loro radici nel passato. E che potrebbero convincere anche chi degli antidoti «nuovi» non si fida più di tanto. Ai no-vax più irriducibili, peraltro, nessun vaccino sarà mai gradito. «La no-vaxite è un fenomeno antico tanto quanto il vaiolo, un flagello dell’umanità. Qualcuno ha detto che fece più morti di tutte le guerre messe assieme» ricorda Cauda. «Anche allora c’erano resistenze in nome della libertà. Finché, grazie ai vaccini, nel 1978 il virus fu eradicato dalla faccia della Terra».