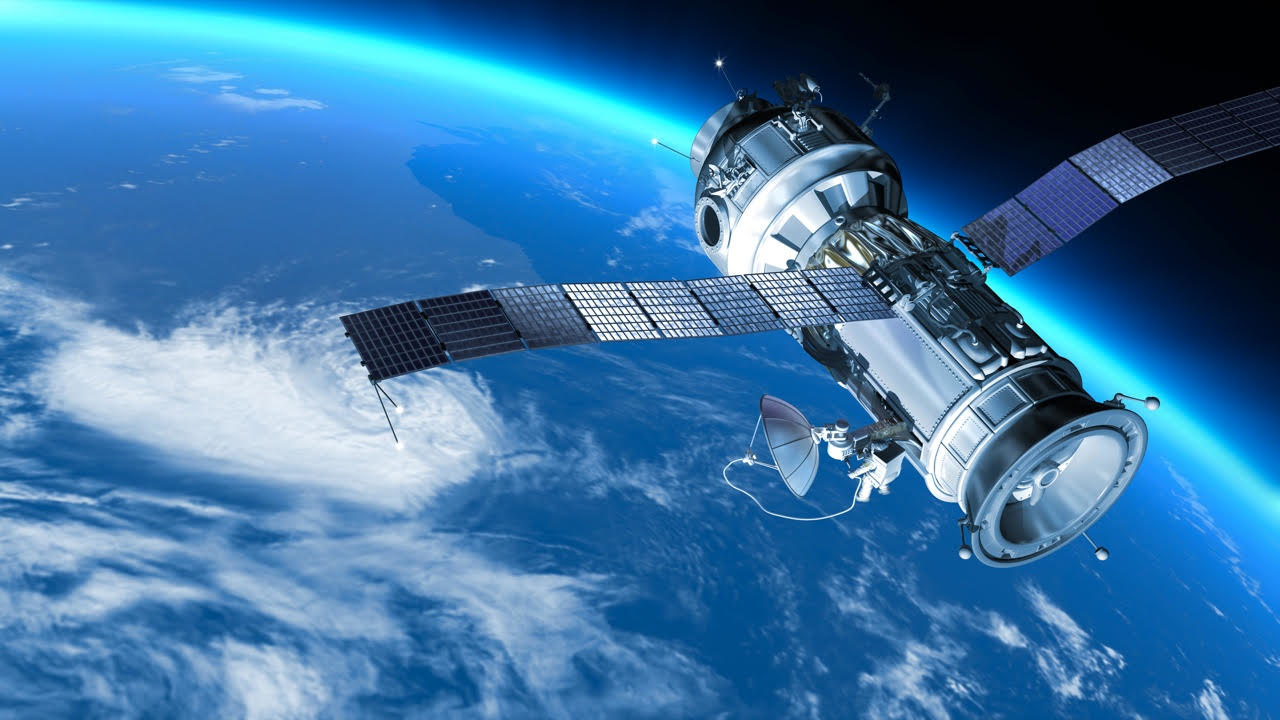Un passo oltre l’atmosfera si sta consumando la più grande corsa all’oro dell’età moderna: la conquista dello «spazio vicino» a colpi di satelliti. Che si affolleranno a decine di migliaia sopra le nostre teste. Commerciali, spia, militari o per scopi civili. Un business trilionario da offuscare il cielo.
GUARDA I VIDEO ESCLUSIVI DELLA NASA
Avviso ai romantici: quelle belle notti passate a rimirare il firmamento presto avranno una magia diversa. Perché a risplendere lassù, tra l’Orsa maggiore e Venere, non ci sarà più una distesa di stelle, ma di satelliti. A decine di migliaia. Hanno iniziato a dispiegarsi appena fuori dalla nostra atmosfera e finiranno per affollarla. Perché l’«orbita terrestre bassa» è oggi meta di una corsa all’oro senza precedenti. Spazio vicino, ultima frontiera.
Molto è cambiato da quando spedire un satellite nella volta celeste era un’operazione imponente. Grande satellite significava grande razzo e grandi portafogli. Solo le potenze mondiali potevano affrontare ricerca, sviluppo, lancio. E i count down di Cape Canaveral venivano trasmessi in tivù. Poi, sono arrivati i telefonini. Il business ha portato a investire sulla miniaturizzazione di tecnologie avanzate, destinate a oggetti che stanno in un palmo di mano. Gli ingegneri spaziali hanno sfruttato quei progressi e creato nuovi modi per ridurre ingombri, peso e costi dei satelliti. Arrivando a oggetti piccoli come scatole da scarpe e anche meno, dai nomi bizzarri (PocketQubes, TubeSat, SunCubes…) e classificati in base al peso: dai microsat (10-100 chili) ai femtosat (meno di 100 grammi).
Sono lanciati senza sosta da agenzie spaziali, Stati, università e istituti di ricerca, società private e pubbliche. Spesso funzionano in «costellazioni», ovvero gruppi di satelliti che sfrecciano insieme sulla stessa orbita, e «megacostellazioni». Vengono caricati numerosi sui singoli razzi, in gergo «lanciatori», che a loro volta sono diventati assai più comuni e agiscono da «autobus» spaziali su cui clienti diversi prenotano un passaggio in orbita per il loro piccolo manufatto, condividendo le spese. Ultima fermata Low Earth Orbit (orbita terrestre bassa), in acronimo Leo: tra i 160 e i 2 mila chilometri di altitudine.
Per intuire il fenomeno basta un recente report della banca d’affari Morgan Stanley, che per il settore spaziale ha previsto un giro d’affari globale di 22 miliardi di dollari nel 2024, 41 miliardi nel 2029, un trilione nel 2040. Enormi profitti sono previsti per il settore delle telecomunicazioni. Il segnale di ogni cellulare della Terra passerà un giorno dallo spazio, consentendo a chiunque di usare internet e la Internet of Things con le stesse prestazioni, che si trovi nel deserto come a New York. Su questo tema è in corso una competizione verticale tra giganti dell’ingegneria spaziale e dell’hitech, cui si aggiungono moltissime start up intorno al globo che approfittando del crollo dei prezzi offrono i loro progetti a privati. La «costellazione» attiva più grande in orbita è quella di SpaceX, l’azienda spaziale di Mr. Tesla, Elon Musk. A oggi vanta 240 satelliti (lanciati a gruppi di 60: gli ultimi il 29 gennaio), ma il suo progetto Starlink ambisce a fornire internet a ogni centimetro del globo terracqueo grazie a una rete prima di 12 mila, infine 30 mila satelliti. Per lo stesso motivo la britannica OneWeb sta lanciando i suoi 650 satelliti, Amazon ambisce a 3.200 (costellazione Kuiper), e lo stesso si approntano a fare Facebook ed Apple. Ma sono soltanto le più famose fra tantissime.
«Sta accadendo qualcosa che fino a dieci anni fa era impensabile» commenta Francesco Topputo, del dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, il cui rivoluzionario e premiato progetto Extrema porterà a realizzare un cubesat (modulo di 10 centimetri di diametro e dal peso 1,3 chili) che esplori l’Universo profondo sfruttando un’Intelligenza artificiale avanzatissima e micropropulsori, senza il controllo di onerose stazioni terrestri. Insomma, è uno che lo spazio lo conosce bene. «Ormai ci sono aziende che propongono soluzioni chiavi in mano a privati e clienti istituzionali. Se vuoi mappare una regione o avere una rete di comunicazioni indipendente basta chiedere e ti lanciano 80-100 satelliti ad hoc. Ti fai la tua costellazione».
Dall’alto dei cieli, con tecnologie che possono vedere anche sotto le nuvole, si osserva e fotografa ogni cosa. È fondamentale per lo studio dei fenomeni, innanzitutto, come dimostra l’esempio virtuoso di D-Orbit, avanzata azienda spaziale italiana, capofila nel progetto Noctua per monitorare il territorio lombardo. «Il nostro satellite collezionerà dati che saranno poi inseriti in una piattaforma accessibile a cittadini e istituzioni» spiega Eleonora Luraschi, manager della società di Fino Mornasco (Como). «Attraverso le nuvole si vedono spostamenti dei ghiacciai e frane, fiumi e laghi, aree urbane e rurali, oltre ovviamente alle infrastrutture. In caso di disastro consentirà un intervento più tempestivo, anche perché si riesce a vedere cosa accade nel sottosuolo più prossimo».
Ma D-Orbit si occupa anche di altro. A marzo lancia il suo primo Ion, satellite di un metro cubo che contiene cubesat da rilasciare nello spazio. La grande novità è che se finora si è costretti ad accettare l’orbita che viene decisa dal cliente principale del lanciatore, una volta lassù il «carrier» Ion si sposterà grazie alla propulsione autonoma e recapiterà ogni satellite che ha in pancia all’orbita desiderata. Sartoriale. «Saremo i primi con questo tipo di tecnologia in Europa, si può dire che siamo i pionieri» commenta Luraschi.
A proposito di osservazione, nel carico di Ion ci sono anche cubesat dell’azienda americana Planet Labs, il cui scopo principale è fotografare la Terra in tempo reale. Ha già lanciato 150 satelliti, ma siccome sono molto piccoli e l’area da riprendere molto grande, continueranno a spedirli lassù finché non avranno coperto ogni latitudine. Sul portale Planet.com chiunque può registrarsi e, pagando un abbonamento, vedere cosa accade in un dato luogo oppure andare indietro nel tempo e controllare cosa è successo ieri o due mesi fa. Monitorare il transito in un certo porto, seguire le modifiche a un’installazione petrolchimica, vedere come la Corea del Nord amplia gli edifici dove produce missili balistici intercontinentali. Ci si iscrive e si sbircia. Con buona pace della privacy di Kim Jong-un, ma anche dei nostri vicini di casa.
Osservare è la chiave anche dello spionaggio stellare ed è ovvio che sia in grandissima ascesa, così come l’uso militare che si fa dei satelliti. Alcuni esempi? La Francia ha parlato di armare entro il 2030 nanosatelliti con laser e mitragliatrici per difendere i suoi veicoli spaziali, mentre nel 2023 lancerà una piattaforma lunga 115 metri nella stratosfera a fini di intelligence. La Cina, la cui attività spaziale sta subendo un’accelerazione impressionante, pare userà un laser satellitare per rilevare i sottomarini nemici fino a 500 metri di profondità. Leader rimangono gli Stati Uniti, che hanno appena ratificato la creazione della sesta Forza armata, la Space force.
Ma la verità è che tutti vogliono occupare il loro «binario» di orbita bassa, qualunque sia lo scopo. La Turchia sta per svelare il proprio programma spaziale. L’Iran pare annuncerà presto il suo primo satellite. Ma anche Paesi come il Rwanda, che è in Leo da novembre, e il Principato di Monaco, che attende con orgoglio il primo lancio nei prossimi mesi, vogliono esserci.
Tanti sono anche i progetti curiosi dei privati, dall’affidare allo spazio le ceneri del caro estinto al creare spazi pubblicitari di dimensione cosmica visibili a miliardi di persone, sei minuti alla volta. La giapponese Star Ale poche settimane fa ha lanciato in orbita un satellite per sperimentare stelle cadenti artificiali, in pratica filamenti di plasma colorato che scendono nell’atmosfera «come una pioggia di meteore», scrivono sul loro sito. Uno spettacolo che pare lascerà a bocca aperta durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, il 24 luglio.
«La nostra orbita bassa si è trasformata in un Far west» sospira Francesco Topputo. «Ci sono opportunità imprenditoriali enormi, certo, ma in mancanza totale di regole. Oltre i 100 chilometri si esaurisce lo spazio aereo su cui i singoli Paesi hanno competenza e da lì in poi vale tutto. Sì, stanno provando a costituire entità che gestiscano il traffico spaziale, ma va fatto con una certa urgenza» rileva lo scienziato. «Soprattutto per evitare collisioni, un problema serio». Tanto serio che il 30 gennaio due satelliti si sono «sfiorati» a 53 mila chilometri orari sopra il cielo della Pennsylvania. E in settembre un satellite europeo ha dovuto cambiare posizione per non essere centrato da un cubesat della costellazione Starlink. Si poteva ripetere l’incidente del 2009 in cui un satellite americano e uno russo si scontrarono generando 2.500 detriti cosmici. E di più detriti non abbiamo bisogno: a oggi quelli maggiori di 10 centimetri sarebbero 22 mila, quelli minori 170 milioni. Il terrore di ogni addetto ai lavori è la sindrome di Kessler: la reazione a catena causata da uno scontro tra satelliti che provocano migliaia di detriti incontrollabili che a loro volta fanno esplodere altri satelliti, e così via. Un evento che inquinerebbe per decenni l’orbita con una cintura di spazzatura spaziale. «Con una collisione simile» spiega Topputo, «ci giocheremmo quella fascia di spazio per sempre. Ma la sensibilità della comunità sta aumentando e si cercano nuovi modi per evitare collisioni». Anche se, guardando quanti satelliti arriveranno in orbita, viene da pensare che sarà inevitabile.
I maggiori oppositori a questo «Far west» per ora sono gli astronomi, sul piede di guerra dopo che il lancio della costellazione Spacelink in novembre ha sconvolto le loro osservazioni spaziali con scie luminose difficilmente trascurabili. «I nuovi satelliti possono essere una minaccia esistenziale all’astronomia», ha scritto il New Scientist nelle settimane scorse. «Siamo indubbiamente allarmati» commenta anche Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica. «I satelliti in orbita saranno tantissimi e potrebbero avere un forte impatto sulle osservazioni astronomiche. Senza contare l’invasione dello spettro radio. Ma ricordiamoci che il progresso produce anche effetti indesiderati. Chi sviluppa tecnologie è sempre più avanti di chi deve regolamentarne gli effetti. Sta pure a noi scienziati mitigarli. Rimbocchiamoci le maniche».