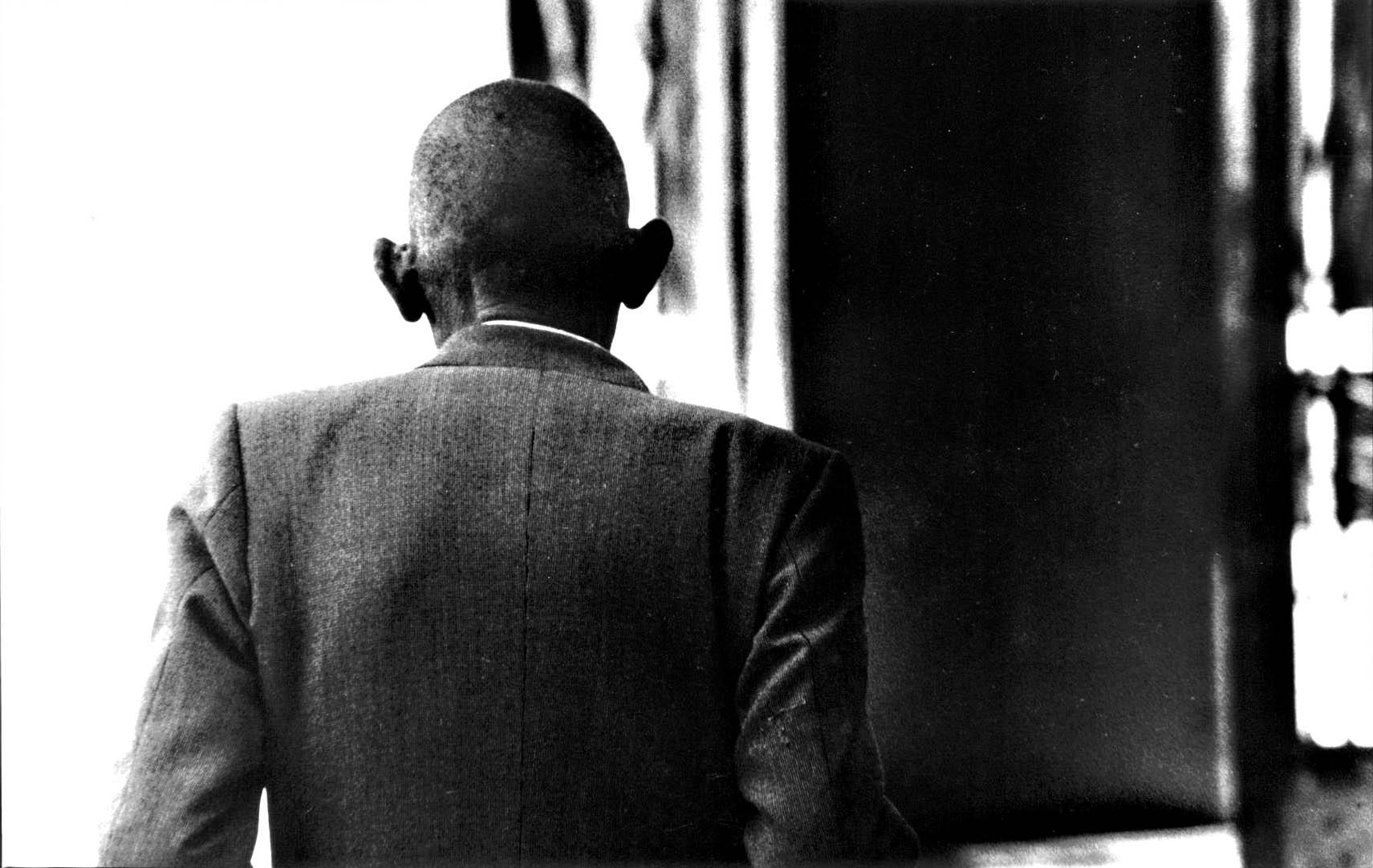In Italia i pazienti psichiatrici sono lasciati a loro stessi e alle loro famiglie. I centri che dovrebbero prenderli in cura non sono attrezzati, hanno fondi scarsi e personale insufficiente. Così, troppo spesso, succede che chi soffre di disturbi mentali aggredisca persone in modo casuale e arrivi anche a uccidere. Come testimoniano i recenti episodi di cronaca.
13 giugno 2021: uno squilibrato psichico, sfuggito alla rete di assistenza sanitaria e sociale, uccide ad Ardea (Roma) due bambini e un anziano. Un anno prima l’uomo, Andrea Pignani, era stato ricoverato nel vicino ospedale di Ariccia per una «consulenza psichiatrica» a seguito di un grave attacco di ansia. 23 giugno 2021: a Pieve di Soligo (Treviso) una donna di 35 anni, Elisa Campeol, viene assassinata mentre prende il sole sul greto del fiume Piave: 10 coltellate da un uomo che non conosce, Fabrizio Biscaro, da tempo in cura presso i servizi di salute mentale di zona.
Si potrebbe continuare con altri esempi analoghi, andando indietro nel tempo, ma anche solo questi due ultimi casi, a distanza di pochi giorni uno dall’altro, ripropongono il dramma sociale della mancata attuazione dei principi contenuti nella legge 180 del 1978. Fra le altre cose, questa che è altrimenti nota come Legge Basaglia, decretò la fine dei manicomi per inserire gradualmente nella società i pazienti psichiatrici. Nel 2014 è poi entrata in vigore la legge 81 con la chiusura definitiva di tutti gli Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari), lasciando il nostro Paese, caso unico al mondo, senza strutture di detenzione per i rei malati di mente.
Se le intenzioni del legislatore erano motivate da principi condivisibili, è indubbio che i malati psichiatrici, così come le loro famiglie, sono stati abbandonati. Liberi di fare del male a se stessi e ad altri. Secondo i dati disponibili più recenti, ogni anno almeno 70 persone rimangono vittime di chi soffre di gravi disturbi psichici; che spesso, una volta arrestati, sono assolti come infermi di mente, e quindi non punibili con il regime carcerario, creando alla magistratura l’ulteriore problema di trovar loro una collocazione.
Un corto circuito istituzionale fra magistrati e corpo sanitario che deve far fronte a situazioni estreme senza avere strumenti adeguati per operare e spesso deve svolgere il ruolo, che non gli compete, di controllo sulla pericolosità sociale del paziente. L’unica soluzione, come fa notare la psichiatra della fondazione Don Gnocchi di Milano, Miolì Chiung, sarebbe intervenire prima di un atto criminoso. «Tutti i malati di mente danno ampi segnali del proprio stato, prima di compiere gesti violenti. La pericolosità si potrebbe contenere se si intervenisse per tempo. La riforma purtroppo non ha pensato a tale aspetto, ma solo a chiudere posti fatiscenti senza sostituirli in modo adeguato».
Una delle maggiori difficoltà è quella di trovare un posto libero nelle strutture Rems (Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza per accogliere responsabili di reati affetti da disturbi mentali), nate con la riforma per sostituire in qualche modo gli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari. In Italia, ne esistono appena 30, che possono ospitare in tutto 600 persone, a fronte di una richiesta quasi doppia di posti letto.
Le Rems non sono controllate come lo erano i vecchi ospedali giudiziari: al loro interno sono ammesse solo guardie giurate e non poliziotti penitenziari come negli Opg, e non è possibile operare alcuna forma di costrizione (tranne nel caso del Tso, con tutti i limiti che la riforma ha imposto al Trattamento sanitario obbligatorio, togliendo la «pericolosità sociale» dai requisiti per poterlo effettuare). Chi ci lavora deve spesso convivere con situazioni particolarmente difficili, per carenze strutturali, di fondi, posti e personale. Secondo i dati dell’Associazione di psichiatria italiana, oggi in Italia ci sarebbero 600-800 mila malati psichici gravi.
A fronte di questi numeri, le risorse destinate alla psichiatria rappresentano appena il 3,5 per cento della spesa sanitaria nazionale, contro l’11 per cento della Gran Bretagna, il 12 di Francia e Germania e il 15 della Svezia. «Questo provoca carenze organizzative e strutturali che hanno ricadute sulla gestione dei malati» dice Giuseppe Nicolò, direttore di tre Rems del Lazio. In 14 regioni il personale è al di sotto degli standard previsti dalla legge, soprattutto nel Centro e al Sud. Mancano professionisti a tutti i livelli: medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori/tecnici della riabilitazione. Soprattutto, a causa dell’aumento dei carichi di lavoro pro capite, i livelli di stress tra gli operatori aumentano a dismisura. Senza contare che, come spiega Nicolò, il costo giornaliero per un paziente ricoverato in una Rems è di circa 200 euro al giorno contro i 30 dei vecchi Opg.
Alla fine il problema ricade in maniera drammatica sulle famiglie dei malati, obbligate a convivere con situazioni-limite, senza il supporto da parte delle istituzioni sociali e sanitarie. Storie come quella raccontata da Maria, 70 anni, che a Vicenza vive con un figlio 43enne schizofrenico da 30, sono all’ordine del giorno: «Lo vedo rovinarsi sempre di più. Ha perduto ormai quasi tutti i denti, ha una nevralgia facciale per le notti passate dormendo fuori casa anche al freddo. Soffre di manie di persecuzione e, quando si manifestano le crisi, scappa dove capita. Come madre non posso che stare con lui e faccio una vita precaria: da un’amica, da un parente. Come si può andare avanti in questo modo? Le rare volte che ho potuto farlo ricoverare obbligatoriamente in ospedale con un’iniezione di Moditen (un farmaco antipsicotico, ndr) tornava quasi normale. Fuori, però, nessuno lo segue, né lui ascolta me o i parenti e si ricomincia daccapo…».
Certo, nei casi estremi, resta la scorciatoia del Tso che è però una misura temporanea (massimo sette giorni di ricovero forzato), finalizzata esclusivamente alla salute e alla sicurezza del paziente e senza alcun esplicito riferimento alla pericolosità sociale. Il «trattamento» può essere deciso dal sindaco del comune di residenza del malato, su prescrizione medica, entro 48 ore dalla richiesta. Secondo una ricerca Censis del 2019, a occuparsi dei malati mentali «h24» sono per il 54,8% dei casi i genitori, per il 19 per cento i fratelli e sorelle e per l’11 per cento i partner, con ricadute pesantissime sia dal punto di vista economico sia sociale e professionale.
«Con la legge Basaglia si sono chiusi i manicomi, luoghi pubblici obiettivamente deplorevoli ma, seppur senza volerlo, sono stati aperti tanti piccoli “manicomi familiari”. Qui il controllo non è nelle mani di medici e personale competente, ma in quelle degli stessi malati che di rado vogliono curarsi, perché il disagio mentale non è quasi mai accettato da chi ne soffre, che crede di star bene e “detta legge” in casa». A parlare è Rosanna, madre di un figlio di 53 anni, da 24 affetto da schizofrenia acuta, che ha malmenato lei e il marito e ha dato fuoco all’appartamento di un vicino che non gli apriva la porta. «Quando c’è stato quell’incendio sono venuti gli operatori del Cim, il 118, le forze dell’ordine, una quarantina di persone in tutto. Lui è stato ricoverato nel solito reparto ospedaliero di Diagnosi e Cura, ma è stato dimesso e tutto è ricominciato come prima. Non si cura e il Servizio psichiatrico se ne disinteressa».
Spesso ci si affida alle associazioni create dai familiari, come Arap (Associazione per la riforma dell’assistenza psichiatrica), che dal 1981 si occupa di sostegno alle persone affette da disturbi mentali. Ma, come dice a Panorama Luciano Prando del direttivo dell’associazione, nei casi più gravi di malattia la situazione dei familiari è quasi sempre drammatica: «O ci si mette in coda, aspettando il turno di una visita specialistica, o si va al pronto soccorso, o si richiede un Tso. Comunque non è prevista assistenza domiciliare. Viene prescritta una cura, che si può seguire o meno, o un ricovero che sarà brevissimo, e che si può rifiutare. Si può anche chiedere un inserimento in una struttura residenziale o semi-residenziale, ma a tempo determinato… La criticità del sistema è qui: la famiglia non accetta di ufficializzare la malattia, chi soffre del disturbo non vuole il ricovero, spesso assume terapie in modo irregolare o si “autocura” con sostanze stupefacenti. Anche i ricoveri non prevedono un’assistenza graduale che coinvolga i parenti». Alla fine è sempre la famiglia che deve improvvisarsi psichiatra, psicoterapeuta, infermiere o carceriere. Ma più spesso, conclude Prando, «ha la funzione di un punching ball».