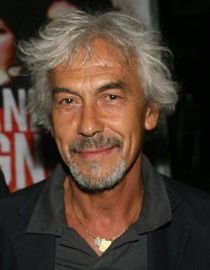La Rivoluzione d’Ottobre e il cinema: ai confini della realtà
Al centro del progetto culturale leninista, lo schermo degli anni Venti si riempì di idee e autori: da Vertov a Ėjzenštejn, da Pudovkin a Kulešov
Un atto formale e una premessa sostanziale. Cent’anni dopo la Rivoluzione di Ottobre si riflette e si continua a dibattere, a livello critico e non solo, sul cinema del prima e del dopo; e sull’influenza e i condizionamenti che l’evento storico-politico ha avuto nell’evoluzione del linguaggio cinematografico.
L’atto formale è quello del 27 agosto 1919, col quale Lenin decreta “il passaggio dell’arte cinematografica nelle mani del popolo vincitore”, segnando di fatto la nascita di un cinema sovietico come arte di massa capace di “esprimere idee rivoluzionarie d’avanguardia e di comunicare ai lavoratori strumenti di conoscenza e di cultura”. In sostanza è un decreto di nazionalizzazione che potenzia il cinema dell’Urss e in particolare la Scuola Statale di Mosca, seguendo un progetto di ampio e ben calcolato respiro culturale nel quale inserire il cinema al centro come “la più importante delle arti”.
L’indicazione, abbastanza esplicita ma al tempo stesso generica, è quella di dare ai film prodotti dal comunismo un segno e un proposito d’immediatezza di tipo documentario, aggiungendovi anzi la definizione di cronaca.
Ricerche espressive spesso in contrasto fra loro
La cosa, però, non è così semplice nella sua determinazione e nella sua contestualizzazione. Ed ecco la premessa sostanziale. Se quel programma di massima può sembrare esplicito ed elementare sul piano pratico, non può esserlo altrettanto su quello teorico. Perché in quel tempo già coesistono, cozzanti fra loro in una sorta di magma indisciplinato e tumultuante, gl’impeti di una ricerca espressiva spesso contraddittoria, fatta di voci e polemiche, invettive e scomuniche, contrapposizioni e ambiguità come nel caso del posizionamento futurista. Insomma, un tessuto dialettico confuso e a volte piuttosto scalmanato.
Del resto il programma leniniano coincide con una revisione in atto nel vecchio cinema europeo, fino ad ora impegnato ad inseguire produzioni un po’ stantìe sul modello del romanzo popolare o sull’esemplare del cosiddetto racconto “borghese”, il primo derivato dalla tradizione della grande narrativa, il secondo sviluppato in complessi àmbiti psicologici. Tutto questo agitarsi in termini di causa ed effetto ha un nome e una provenienza: David Wark Griffith, Stati Uniti d’America. Cioè quanto di più remoto si possa immaginare rispetto al contesto sovietico.
La “sconvolgente” novità arrivata dagli Stati Uniti
Nascita di una nazione (1915) e Intolerance (1916) cambiano il mondo del cinema e la maniera di intenderlo, di farlo e di leggerlo. Lo spettatore d’Europa, assuefatto alla percezione di una realtà artificiosa edificata su scenografie di cartapesta e immagini provenienti solo dagl’interni degli studi, si trova adesso catapultato in una iconografia e in una forma narrativa del tutto sconosciute. Riprese in esterni e panorami, attori non più ostaggi passivi della recitazione e della gestualità “teatrali” ma autentici protagonisti in termini di fresca immediatezza se non addirittura di spontaneità, fisicamente congrui alle loro parti: un cinema – è qui l’aspetto fondamentale – che scommette su un’altra rivoluzione, quella del montaggio e della sua nuova metodologia (“all’americana” o parallelo come viene definita la progressiva alternanza di inquadrature legate a due o più segmenti narrativi, a volte contrastanti, fino alla loro dissoluzione e alla riaggregazione finale) in grado di regalare al pubblico emozioni e attenzioni sconosciute.
Ecco il dilemma su identità e appartenenza
Dunque Griffith, prima di tutto e davanti a tutto. Ha un bel dire e un bel pensare, Lenin. Vero, la rivoluzione porta con sé la necessità di una riflessione politica sull’utilizzo del cinema. Ma gli studi, il dibattito e le novità del periodo – sostanze di portata incredibile per un’arte nata da poco e così intensamente mobilitata su forme e contenuti – prescindono dallo scenario storico-politico in sé e restano un cardine nell’evoluzione del cinema tout court. C’è una certezza perciò: non esiste un cinema “della” rivoluzione ma un cinema che “nella” rivoluzione sviluppa, determina e perfeziona un dibattito teorico-pratico anche in base ai suoi indirizzi politici e sociali.
“Far ridere, far piangere, far attendere” lo spettatore
Quando Vsevolod Illarionovič Pudovkin - dopo un breve percorso (fino al 1921) al fianco del maestro Vladimir Rostislavovič Gardin orientato alla prassi cinematografica - entra nella Scuola di Mosca, Lev Vladimirovič Kulešov sta saggiando la metodologia americana e imbastendo uno studio sistematico delle potenzialità del montaggio.
Per Pudovkin, se non proprio una illuminazione, quella pratica è un segnale decisivo e si accosta con interesse e entusiasmo alle teorizzazioni del regista di Tambov, considerato ancora oggi uno dei grandi profeti della scuola sovietica del montaggio. È un momento d’oro di una prassi nella quale Griffith cede ciecamente e vi sta indicando il mezzo definitivo per “far ridere, far piangere, far attendere” lo spettatore: servendo anche certi meccanismi e filosofie di mercato (americani capiscuola, in questo) per il controllo del pubblico e delle sue reazioni emotive nella prospettiva di programmare, dove possibile, addirittura il successo di un film.
La vita? Meglio coglierla alla sprovvista
Ma è anche il momento nel quale l’iconico Dziga Vertov oppone al montaggio artistico della scuola kulešoviana il suo “registrare diretto”, la sua vita “colta alla sprovvista”, aprendo una delle monumentali dispute sulla natura del cinema e i suoi modi di realizzazione. Del resto, la questione stessa della definizione di un concetto di montaggio è per il cinema – in questa fase di passaggio – il centro di un complesso intrico normativo e teorico peraltro – forse – non ancora risolto.
Da un parte Pudovkin, sotto l’influenza formativa della scuola moscovita, trova proprio nei messaggi dell’industria americana un concreto sussidio ad una discussione sulle potenzialità del mezzo e sulle opzioni teoriche da perlustrare in vista di una sviluppo dell’arte cinematografica.
Con lui, anzi prima di lui, Kulešov: ad impostare la ricerca sui materiali del cinema per dimostrare il “carattere ideale” del montaggio mettendo in secondo piano le altre componenti di un film come la scelta delle inquadrature, la direzione degli attori, i nodi di ripresa e via così. Tutti elementi da riordinare nel montaggio per la creazione del film, momento, diciamo così, topico per dare fisionomia logica ed espressiva all’opera attraverso le regole formali “esterne” all’inquadratura in quanto tale.
Le accuse di formalismo e l’arte “realista”
Risultato: Kulešov viene accusa to di formalismo. Del resto egli si muove nell’ambito della cultura formalista russa del periodo, accogliendo certi criteri metodologici nei confronti di una materia, come il cinema, ancora tutta da scoprire. E se Pudovkin, che lo segue, può separarsi dalle risoluzioni “spettacolari” legate al montaggio secondo Griffith, molto credito lo si deve proprio al “formalismo” del suo collega proprio per quella tendenza a traslocare il centro di interesse dagli effetti emotivi sulla fruizione alla concretezza della pratica artistica.
Altro discorso è che poi questa pratica artistica venga in qualche modo accelerata da Kulešov verso una manipolazione “irregolare” dei materiali cinematografici fino ad un loro sfoggio accademico, contro le logiche di una certa ideologia: in questo senso Pudovkin interviene sulla tendenza in termini di variante correttiva, seguendo la sua concezione dell’arte “realista”.
Idee in un panorama congestionato ed elettrico
Come si vede l’agitazione è grande e un lungo brivido, non solo legato al cambiamento, percorre il cinema sovietico degli anni Venti nelle sue pieghe teoriche. Insomma un panorama congestionato ed elettrico. Da una parte le dispute sul montaggio, dall’altra quelle sulla giusta collocazione del concetto di “realtà”, dall’altra ancora quelle sulla giusta collocazione di un formalismo (i formalisti russi si definiscono “specificatori” – analisi critica della specificità dei materiali e dei processi di costruzione dell’oggetto - sia in letteratura sia, dopo, nel cinema) che elabora la sua teoria cinematografica sull’interazione fra materiali e procedimento in termini di verifica della “elasticità” del materiale filmico, cioè le immagini; sulla differenziazione funzionale dei flussi linguistici, dunque dei varii modelli di rappresentazione; sul concetto di ritmo sviluppato in collegamento con quello del montaggio.
Quelle complicità culturali: una scoperta sorprendente
Al di là dell’adesione effettiva ai dettati ideologici più rigorosi e intransigenti, rimane incontestabile la fitta tessitura di rapporti – perfino di complicità culturali – tra la scuola formalista e alcuni tra i cineasti più importanti di questo primo periodo sovietico. Documentati quelli tra Kulešov e lo scrittore e critico letterario Viktor Borisovič Šklovskij, fra l’altro scrittore Jurij Nikolaevič Tynjanov e i FEKS (Fabbrica dell’Attore Eccentrico) e – molto probabili - quelli fra Sergej Michajlovič Ėjzenštejn e gli stessi Šklovskij e Tynjanov.
Quanto ai FEKS, in particolare a Leonid Zacharovič Trauberg , Grigorij Michajlovič Kozincev e al primo Ėjzenštejn regista teatrale del Montaggio delle attrazioni, si può ben dire che nelle loro opere si ritrovi tutta la sostanza formalista estranea all’orizzonte puramente teorico per inserirsi in indicazioni di poetica. Tendenza che convive con la ricerca formalista di gettare le basi di una “scienza” non condizionata da scelte discrezionali o di gusto estetico.
Il tema dell’oggettività e della sua rappresentazione
Il nodo principale resta comunque quello legato al concetto di “realtà”, a sua volta legato a quelli di oggettività e di interpretazione così determinanti anche per gli interessi e gli scopi del regime. Inevitabile, nel contesto storico e politico, che il primo elemento di analisi sia il rapporto del cinema con la realtà (del resto il mezzo nasce in funzione essenzialmente riproduttiva della realtà medesima). Sul campo c’è il rapporto tra la presunta “obiettività dell’obiettivo”, visto in forma neutra quindi neutrale in quanto vincolato alla sua “scientificità”, e il mondo reale.
Di qui la posizione-chiave della fattografia (“letteratura del fatto” contrapposta ideologicamente e formalmente a quella del passato additata come narcotico sociale) nelle concezioni del LEF (Fronte di sinistra delle arti, la rivista è fondata da Vladimir Vladimirovič Majakovskij, lo scopo individuare una linea comunista in tutte le arti): è il rifiuto di ogni adulterazione artistica con la restituzione, appunto, del fatto nella sua oggettività più immediata.
“Kinoglaz” contro la retorica dello spettacolo borghese
Tesi che trovano in Dziga Vertov, nel suo Kinoglaz (il leggendario Cine-occhio) e nella collocazione d’avanguardia uno dei simboli più luminosi sul tema dell’oggettività significante. Vertov (il vero nome è David Abelevič Kaufman, quello d’arte deriva da iniziali simpatie futuriste e vuol dire “trottola”) si propone, coraggiosamente e genialmente, contro i rischi di un cinema creativamente statico o prigioniero di vecchi moduli espressivi.
Col suo lavoro vuole liberare il cinema dalla “retorica dello spettacolo borghese”, lanciando invettive contro la produzione industriale, cercando segnali di presenza umana nel quotidiano e proponendosi di riconsiderare il cinema come ripartendo dal suo zero: estremizzando il concetto di verità, girando e montando il film nell’intento esclusivo di trasferire fedelmente sullo schermo l’oggetto di ripresa, piegando a quella “fedeltà” ogni aspetto espressivo e contenutistico.
Come cambia il rapporto tra l’occhio umano e la cinepresa
Le dichiarazioni programmatiche di Vertov sono radicali, convintamente comuniste e davvero “rivoluzionarie”. Al tempo stesso, però, la loro impostazione ha una prospettiva individualistica che non piace troppo al regime, certo di poter manovrare a suo piacimento un settore che invece sembra sgusciarli costantemente fra le mani: complice, è evidente, l’incapacità tutta politica di gestire con consapevolezza e mezzi culturali adeguati una materia in piena ebollizione teorica.
Vertov, comunque, è lucido e coglie gli aspetti ideologici dell’utilizzo del mezzo modificando il funzionamento e l’esercizio dell’occhio umano rispetto alla cinepresa. Non più il primo a guidare la seconda (costretta a “copiare” il lavoro dell’occhio), ma la cinepresa stessa a sostituirsi all’occhio ormai svigorito e sfibrato per affermarsi come “cine-occhio” che cerca, scandagliando il “caos dei movimenti”, l’identità del proprio movimento.
Teoria utòpica e immaginaria? Non proprio, basti pensare alla sua applicazione ne L’uomo con la macchina da presa del ’29 e alle sintassi sconvolte di quel film incredibile; e alla lezione che, in un futuro già lontano, sapranno adeguare autori come Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard, sul versante visionario e delirante E. Elias Merhige. Nonostante tutto, però, Vertov non riesce a liberarsi completamente dall’equivoco di fondo dell’imparzialità dell’obiettivo. Un pericolo implicito nel concetto di confusione, sia pure in cifra “rivoluzionata”, nel rinnovato rapporto tra arte e vita.
Le diverse poetiche di due “giganti” della creatività
E quando Ėjzenštejn, l’altro gigante, entra nel gioco della disputa intellettuale può accusare i Kinoki (il gruppo dei Cineocchi coordinati da Vertov) di “impassibile figurativismo”. Di fatto, un’accusa di formalismo. Che in qualche modo associa le esperienze di Vertov e quelle di Kulešov basate sull’autonomia del montaggio e una visione della tecnica solo apparentemente effettiva e fisica, in realtà legata a precisi pregiudizi ideologici.
D’altra parte le poetiche di Ėjzenštejn e Vertov, nonostante la continua, storica e popolare saldatura dei loro nomi all’epopea esplosiva del cinema sovietico anni Venti, sono profondamente diverse e il loro contrasto è di solide basi.
Il movente creativo per accendere la fantasia del pubblico
Vertov è convinto delle potenzialità autosufficienti e libere della macchina da presa, obbligando l’occhio umano a piegarsi alla legge del Kinoglaz.
Ėjzenštejn, al contrario, percepisce la proiezione di un film come movente creativo della fantasia dello spettatore: stimolandolo a “distinguere”, spezzando l’unità del continuum e obbligandolo ad una partecipazione creativa nel conflitto dialettico delle immagini. Dunque senza deleghe al cine-occhio ma utilizzando il cinema nel suo insieme per vedere il mondo reale, non illudendosi di poter cogliere di sorpresa la realtà o assoggettarla ad elementi estranei ai materiali specificamente cinematografici. Niente “copiature” perciò, di elementi estratti arbitrariamente dal sistema abituale delle cose.
La grande potenza del suo cinema sta piuttosto nella creatività tutta interiore delle immagini e della loro derivazione dalla consapevolezza dei valori formali dialetticamente presenti dentro e fuori l’inquadratura.
Arriva la vittoria ideologica nel campo della forma
Sciopero!(1924), prima ancora – e ancor più - de La corazzata Potëmkin(1926) e di Ottobre (1928) è il suo “manifesto” cinematografico, che egli stesso accompagna dicendo: “È ora che almeno qualcuno capisca che la forma viene determinata a un livello molto profondo e non mediante qualche piccolo espediente superficiale più o meno felice”. La sua, sono ancora parole del cineasta, è una vittoria ideologica nel campo della forma. Una “forma rivoluzionaria” piuttosto che un “rivoluzionamento delle forme”. Dunque, secondo Ėjzenštejn, non una ricerca di “forme corrispondenti ad un nuovo contenuto ma la comprensione logica di tutte le fasi della produzione tecnica di un’opera d’arte in relazione a un nuovo tipo di energia, l’ideologia dominante”.
Ricerche possibili anche fuori dal contesto storico-politico?
Domanda finale, destinata forse a rimanere senza una risposta risolutiva e inappellabile: esiste un “cinema rivoluzionario” o esistono autori che trasferiscono nel cinema concetti rivoluzionari? In altre parole: Ėjzenštejn, Vertov e tutti gli altri svilupperebbero le loro idee anche al di fuori del contesto rivoluzionario?
O può esser credibile che la grande importanza data dal regime sovietico al cinema – visto ovviamente anche quale potente veicolo propagandistico e ideologico in opposizione al suo uso capitalistico – spiana davvero la strada alle idee? Da parte nostra ci si orienta ad immaginare un “habitat” politico, sociale e storico molto pertinente all’innovazione, solerte nel “controllo” ma incapace di governare e ispirare in modo diretto i segmenti della creatività reale.
Induce a questo pensiero la grande animazione di autori e correnti impegnati, a loro volta, a istruire nell’area sovietica degli anni Venti un’alternativa “rivoluzionaria” al vecchio cinema e ai suoi modi di produzione: aderendo, sì, ad un auspicato concetto di “fruizione proletaria” e di uso “politico” della macchina da presa, ma spalancando al tempo stesso le porte alle teorizzazioni più estreme sul concepimento della realtà e dei suoi modi di rappresentazione. Vale a dire sull’essenza stessa del cinema.
Per saperne di più
- La Rivoluzione d'ottobre, cosa ci dice oggi
- La Rivoluzione russa, 100 anni dopo